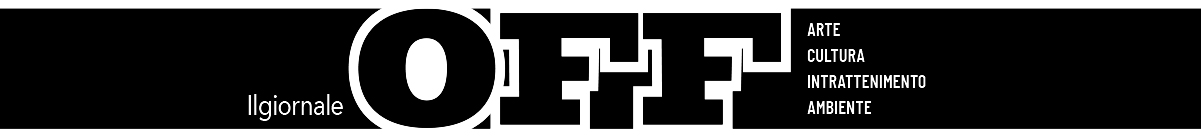Sembrerebbe il racconto di un freddo estremo, invece è il canto di un caldo al contrario, dove “l’ombra ha un suo calore materiale”, un’ombra avventurosa, audace, perfino ottimista: “se avessimo un’anima la vorrebbe/ definire”. Per Francesca Matteoni l’anima è il gelo di un dolore incandescente e originario, e i suoi versi raccolti in Ciò che il mondo separa (Marcos y Marcos, 2021, pp.140, € 20) il resoconto di quei brividi. “Allora il vento è un sentiero./ Lo senti senz’alberi schiudersi i pori, le foglie –/ le sue punte ghiacciate di stella.”
Nel freddo estremo che ti scioglie la carne di dosso, le parole si fanno nette, luccicano. “Noi entriamo nella terra diradata, i boschi/ sbiancati verso l’acqua”. Senti quasi il profumo degli spazi che si allargano mentre si compie il grande tuffo in un nord impossibile da ridurre alla vita che gli uomini hanno scelto, a quello che ne rimane, alla voce delle nostre città, alla confusione – traffico, saluti, incontri senza destino. “Perché il cielo/ quassù/ è una tasca di pioggia – i pochi abeti lo tengono al/ soffitto come spilli”, “ma nell’inverno si è tutt’uno con il cielo.” Solo qui, in un cielo bianco e disertato, puoi notare le cose che contano davvero – “a palme tese sopra il fuoco/ il chiarore brucia, decresce nella pelle” –: che le cose contano sull’attenzione di chi passa.
È perfino bello pronunciare il suono del freddo e della solitudine assoluta, dirlo come giocano i bambini. “Lama lava luce”. I bambini, ma mica tutti. Solo le creature debolissime tra i deboli hanno il talento di indovinare-indivinare. “Ad alcune bambine spuntano/ le ali, ma ad altre le lacrime/ e di quelle posso parlare.” Solo per loro sono certe filastrocche su cui si scivola battendo i pensieri ottusi dentro la nuca: “cadde la palude dal naso/ caddero le braccia giù dai fianchi/ cadde la pelle in spilli e forcine/ cadde la veste e dopo la statura/ caddero gli arti a penne bianche e nere/ si aprirono le ossa come flauti”. Certe fiabe che cominciano dalla fine: “la torre era d’osso e cemento/ e qualcosa come il rimorso”. Certe confessioni: “ero un riflesso delle mie grida”, “mi aggrappavo alla rabbia del freddo”, “una casa e un luogo/ non sono abbastanza per tornare”. Certe morali che fanno guerra alla morale: “tu guarda e impara:/ non sempre chi taglia separa”. Non si sa se il ghiaccio su cui i passi s’ingarbugliano, cercando un nord più a nord ancora, sia la superficie del loro cuore insanguinato. Intanto, “le montagne accennano un tremolio/ la fine dell’inverno”. Inutile cercare, interrogarsi, interrogare. “Sono le cose ultime le stesse delle prime/ viste per caso mentre camminiamo/ nel tempo quasi umano di queste colline”.
Un’unica arte: pungersi il dito e dormire. Andare ancora più su, staccarsi da terra. Sognare.
“Sono cadute le stelle, erano/ lucciole incastrate nei corpi./ Mi sono dimenticata i morti/ o il colloquio solitario/ col posto, il tempo, l’antenato/– mentre ti amavo”.