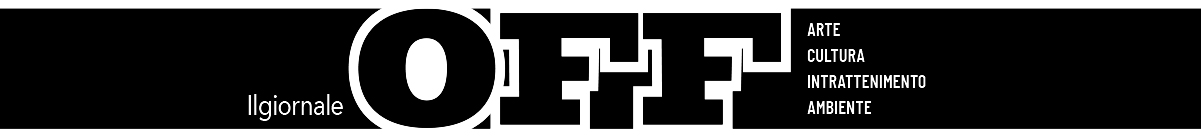Cesare Pavese, tra gli autori più significativi del nostro Novecento, è da sempre imprigionato in due mondi. Un mondo “retorico”, formale, ufficiale fatto di santini politici e ricostruzioni di partito, tra Marx e Gramsci, il neorealismo e le teorizzazioni razionaliste di Lukacs; ed un altro segreto, sacrale, imperdonabile, tra Nietzsche e Vico, suggestioni decadenti e miti irrazionalisti.
A quel mondo, sacro, divo, decadente, appartiene però l’anima profonda del Pavese scrittore, poeta e narratore, la cui impronta però emerge anche nei suoi testi più “neorealisti”, mostrandosi in tutta la sua potenza evocatrice nelle sue opere capitali, come “Dialoghi con Leucò”, “Il mestiere del vivere”, “Il Taccuino segreto”. Opere che mostrano l’anima più crepuscolare e decadente dello scrittore piemontese e la cui sensibilità fa emergere una vocazione per l’irrazionale, per il mistero, per il mito. Tutti elementi che evidenziano il profilo di un Pavese segreto, alla luce del mito e dell’eterno ben rappresentato e immortalato nelle pagine della splendida antologia “Cesare Pavese. Il mito”(Vallecchi editore) curata ed introdotta da Marcello Veneziani. Una antologia che mostra il lato aurorale, originario, mitico di questo autore imperdonabile, che come Pasolini può essere descritto come “una forza del passato”. Marcello Veneziani, che per la casa editrice aveva già curato delle straordinarie antologie su Dante e Manzoni (“I fiori del bene”) nel suo saggio introduttivo, ci mostra un Pavese anomalo, proscritto, proibito che fa del mito la sua identità, profonda, il suo destino, il significato profondo della sua esperienza letteraria e poetica. Scrive, infatti, Veneziani che Pavese: “ritenne il mito il culmine stesso della sua vita letteraria e della sua concezione della vita, il rifugio più alto e più vero per proteggere l’uomo, il mondo, il destino, la poesia, l’intreccio tra vita e morte, senza ricorrere alla fede. Il mito dell’infanzia, il mito delle sue Langhe, il mito della cultura classica, il mito come concezione del mondo e della vita. Scelse nel mito la verità che coincide con la favola, la realtà che si rivela nel racconto; un sentimento originario che precede le categorie dominanti della sua epoca: la dialettica, il razionalismo, lo storicismo, le ideologie politiche, l’impegno sociale, la rivoluzione”. Un mito che Pavese, però, declina aldilà delle pose e delle retoriche del suo tempo: “il mito amato da Pavese girava al largo dalla storia, dalla politica, dalle rivendicazioni di primati, imperi e risorgimenti; il suo era il mito nella sua accezione originaria, classica, esistenziale, tragica. Il mito era la forza segreta della Natura rispetto alle forze motrici della Storia, era l’infanzia cosmica e personale rispetto alla vecchiaia progressiva del mondo; era il paese, la campagna, la civiltà contadina rispetto alla metropoli, alla città, alla civiltà industriale, alla lotta di classe; era la potenza del sacro, dello spirito e dell’anima rispetto alla potenza della materia, della macchina e del numero; era il primato del pensiero simbolico sul materialismo dialettico e sul razionalismo; era l’amore liceale per i classici e per la letteratura, la nostalgia del mondo antico, esiodeo e omerico degli dei, rispetto al realismo socialista e al novecento, gremito di idoli ma povero di dei.”
Nel suo saggio introduttivo Veneziani analizza, approfondisce e rivela la grandezza di questo Pavese proibito, oltre le facili categorie della critica convenzionale, mostrandone l’afflato decadente, numinoso, misterico che ne caratterizza lo stile e le idee. Idee che non hanno nulla a che fare con la critica militante dell’egemonia gramsciana, ma che connettono la filosofia di Vico e lo spirito tragico di Spengler, l’amor fati di Nietzsche e le ierofanie di Eliade. Aspetti controversi ed imperdonabili dell’autore di “Lavorare stanca” che lo renderanno, in vita, inviso, sospetto, compromesso agli occhi di quel feroce “Platone d’esecuzione” che era la critica marxista dell’epoca, che poi frettolosamente lo arruolerà post mortem nelle sue fila. Leggendo questa antologia, invece, si evidenzia in Pavese il più sincero apostolo di una filosofia del ritorno, rivoluzionaria conservatrice ed impolitica, che vede nel mito la liturgia dell’eterno. La forma sacra che usano gli uomini per dare dei nomi agli eventi, alle emozioni, alle proprie paure, al proprio fato. Ade, Prometto, Edipo, Minotauro, Arance, Virbio, come gli altri personaggi dei “Dialoghi con Leucò” (le cui massime arricchiscono gli ultimi capitoli della raccolta) non sono solo bei nomi carichi di destino, ma degli archetipi che si annidano nel nostro inconscio, nello specchio delle nostre anime, nel mistero che nasconde il sacro. In Pavese il mito è uno strumento conoscitivo, una rappresentazione suprema, e soprattutto, come del resto lo è tutta la letteratura, esso è l’enigma dell’uomo. Un enigma che porta il lettore nel labirinto della propria mente, negli abissi della propria anima, perché i personaggi del mito non sono solo le ombre degli uomini che abitano il mondo, ma anche le proiezioni dei tanti “io”, che albergano in una stessa coscienza. Pavese, quindi, sceglie il mito, come un “biglietto di ritorno” per fuggire dalla Storia, per oltrepassare le categorie abusate e comode della dialettica marxiana, il credo degli intellettuali organici, le trappole del razionalismo, ed accedere, finalmente ad una dimensione originaria, irrazionale, eterna.