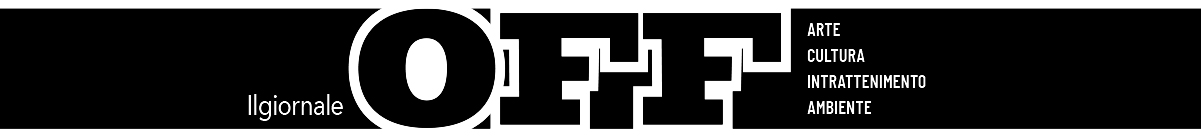Oggi avrebbe compiuto 87 anni. Tre anni fa il cinema aveva dato l’ultimo saluto a Tomas Milian, l’attore di origini cubane (Tomás Quintín Rodríguez Milián), morto il 22 marco 2017 a Miami, che aveva lavorato con Pasolini, Lattuada e Monicelli ma era diventato celebre per aver interpretato due personaggi in più pellicole: Nico Giraldi, un maresciallo (dal 1981 ispettore) di polizia romano dai modi poco garbati ma efficaci, che conosce bene gli ambienti malavitosi avendone fatto parte in gioventù col soprannome de “er Pirata” e Sergio Marazzi, alias “er Monnezza”, un ladruncolo romano. Ma Tomas Milian aveva recitato anche in film di alto livello: apprezzata dalla critica fu la sua interpretazione in “La luna” (1979) di Bernardo Bertolucci e e quella, come protagonista, in “Identificazione di una donna” (1982) di Michelangelo Antonioni. Noi oggi lo ricordiamo con questo bel ritratto che gli fece il nostro Emanuele Ricucci (Redazione).

È una tragedia vedere Starsky e Hutch – Paul Michael Glaser e David Soul – canuti quasi estinti, anche loro. Uno che spinge la carrozzella dell’altro. Straziante indurimento della nostalgia del presente. Che torna a colpire, subito. Pensare a Bud Spencer come un goffo cherubino. Aver salutato Cannavale e Lechner, e poi Toffolo, Albertazzi. Ripensare all’infanzia. Ricordare, per poi poter solo immaginare.
Lo sentivo che stava per crepare anche lui. E disturbato, ero andato a cercarlo. Quasi me lo sentivo. Così, mi ero andato a ricercare una sua lontana intervista, in Rai. Ero andato a ricordare, a rasserenarmi, vigliaccamente a pensare che quel tempo non finisse mai. Quando avevi un nonno che ti prendeva sulle gambe e rideva quando un buffo tizio vestito con la tuta da meccanico, come un arlecchino, con le spillette sul cappello, tirava uno sberlone in testa ad un impacciato malandra romano che girato di spalle chiedeva: “chi è?” e si sentiva rispondere: “so’ l’anima de li mortacci tua!”.
Il barbone folto, nero. I capelli ricci corvini, come una donna greca. Pippo Baudo parlava con Tomas Milian. E lui, senza matita nera sugli occhi e, soprattutto, senza la voce che lo ha reso immortale, quella di Ferruccio Amendola, parlava una lingua meravigliosa: il romano. Che è il blues di chi viene da niente e ha il cuore enorme. Che è poesia della scanzonatezza, la cadenza della furbizia, da Rugantino a Tomas Milian. Certo, il suo era un romano accennato, che si mischiava con l’italiano e qualche caduta anglo-spagnola. Perché Milian, o meglio Tomás Quintín Rodríguez Milián, era cubano. Era figlio di un generale alla corte di Machado, prima che Batista gli sottrasse il potere. Prima che, tornato dall’esilio impostogli dal rovesciamento di fronte, il padre Tomás gli si ammazzasse davanti agli occhi. Un figlio di un popolo che canta, come poteva non finire a Roma, dove parlare è cantare, e muovere la mascella, agitare le mani e le braccia, e fermarsi a bocca aperta, davanti al Colosseo e alla Colonna Traiana, come anche alla fine di un lungo insulto rivolto a qualcuno, è la normalità.

Baudo incalzava Milian, che ricordava semplicemente di essere uno venuto dal nulla. Che aveva fatto l’imbianchino a New York. Venuto dal nulla, ma mai che non fosse nulla, nei suoi personaggi, apparentemente gretti, vuoti, sterili, farseschi. Che fosse Nico Giraldi, il poliziotto, da giovanotto un piccolo malavitoso, o Sergio Marazzi, per tutti er Monnezza, oppure un pistolero degli spaghetti Western, Milian era tra le braccia dei più grandi a riempire i contorni di una commedia che tra un vaffanculo e l’altro trovava sempre la sua redenzione: il criminale poteva crescere e capire, come il maresciallo Nico; il criminale era uno che interpretava la strada e in ogni schiaffo che riceveva c’era una morale; era un burbero che perdeva sempre, ovunque fosse, sarebbe stato trovato e condannato, perché il bene, tra un ceffone e una rivoltellata, vinceva sempre, perché il carisma dell’uomo che non si nega a se stesso, e la virilità, vincevano sempre. Era tra le braccia dei grandi, Milian, tra quelle di Cocteau, con cui iniziò tutto nella sua Italia – una pantomima al Festival di Spoleto del ’59 -, così come quelle di Bruno Corbucci, Bernardo Bertolucci, Michelangelo Antonioni – con cui riscoprì il senso della drammaticità -, Alberto Lattuada, Luchino Visconti e Mauro Bolognini, che per primo credette in lui quando arrivò nello Stivale con appena qualche dollaro in tasca. Registi mitologici, che Dio li benedica per aver dato un’immagine al tempo. E poi Broadway, gli States, quelli della fuga da ragazzino e quelli della maturità cinematografica, con Tony Scott, Oliver Stone, Steven Spielberg, Steven Soderbergh e tanti altri.
Sembrava nulla. Ma Milian, e il mondo dei suoi personaggi, è una terzina del Belli letta con un sigaro in bocca, all’ombra di un bar di Campo de’ Fiori, durante la primavera, ritratto in un angolo, mentre il vociare del mercato sovrasta tutto. Un’ indimenticabile e piacevole trasgressione. Un cinema sporco e sudato.

Romanticamente espressivo. Antieroico – mai paladino, ma bandito o criminale convertito -, erotico. Maschio. Un buono tra cattivi bonaccioni, in un’epoca in cui una “buona” contestazione, significava un’ottima carriera: “«Non sopporto quelli che si proclamano rivoluzionari, che parlano sempre dell’eversione e poi finiscono per non fare nulla. Non solo, ma si recano alla dimostrazione sulla bella auto di papà e d’estate sospendono le agitazioni perché devono andare al mare, sono contestatori questi?». «Non ha paura a proclamare queste idee?». «E perché? Uno deve fare la propria scelta di vita. Perché mi devo mettere a fare l’arrabbiato, l’impegnato? Forse perché va di moda? Io non voglio scendere a questi espedienti. Se il pubblico mi vuole, mi deve accettare come sono. Almeno avranno la sicurezza che sono sincero, che non prendo in giro», come disse in un’intervista nel 1971, lo stesso in cui Pablo Neruda vince il Nobel per la Letteratura, lo stesso in cui viene reso noto all’Italia il tentativo di Golpe da parte di Junio Valerio Borghese del dicembre dell’anno precedente.
Fa male realizzare. Realizzare che la poesia di un tempo s’è persa nel vento, mentre cadono uno dopo l’altro i punti di riferimento. Tutti. Disincantata, possibile, comica, rasserenante. Versi versati, come lacrime, sorridendo, nel nuovo che avanza e che a forza di avanzare rischia di marcire. Che ti fa, per un po’, dimenticare il mito, quello che ogni tanto vai a ricercare per sentirti sicuro che quel tempo non passerà mai, per sentirti rasserenato e, a suo modo, legato ancora al ricordo proprio di quel tempo meraviglioso. Ma alla fine è giusto così: il cappello del mito è l’eternità. Già elegante ed affascinante di per sé. E l’eternità non si costruisce solo in vita, si sancisce con la morte. Proprio come accade per questo Paese morente, che nella musealizzazione inquietante di se stesso, va a cercare il suo volto da giovane, la sua identità, nel tempo che fu, l’ultima Italia. Che vive nel mito di se stessa. La rende un museo, e ci va tutte le domeniche di crisi. Gli italiani ci portano la famiglia a vedere Craxi, Totò, il Totocalcio, Macario, il mare pulito, il pesce fresco, Pavarotti, le cozze a Taranto mangiate crude, il mondiale ’82, il grande Milan e il Festivalbar. Guarda com’eravamo. Forse saremo eterni, altrimenti, “so’ uccelli aspri. E che vor dì a ispetto’? Che so’ cazzi amari!”