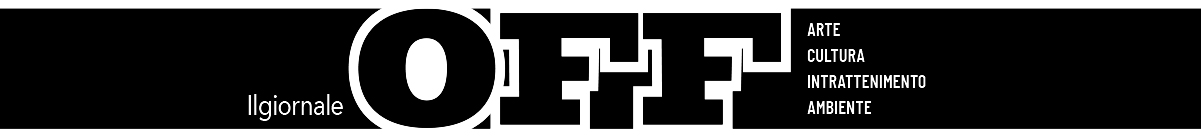Si dicono antifascisti e continuano a farlo: anche dopo avere legato e massacrato un militante di Forza Nuova (Palermo), anche dopo aver imbottito di chiodi le bombe carta contro un poliziotto (Torino), anche dopo aver detto che i poliziotti devono morire (la professoressa “di lotta”, sempre Torino): ultimo episodio in ordine di tempo l’attivista di CasaPound aggredito a bastonate a Livorno. Episodi di gravità inaudita, di violenza forse nemmeno equiparabile a quella degli anni Settanta, quando pure i fronti erano contrapposti a suon di spranghe e P38. C’è un problema ed è un problema grave: i giornaloni non ostili al governo (mettiamola così) non registrano l’estrema gravità di quanto sta accadendo da parte degli autoproclamati antifascisti a danno di quelli che identificano come il nemico da abbattere col fucile (parole dette espressamente dalla succitata prof di Torino, basta ascoltare l’audio). O meglio, registrano la notizia come si trattasse di qualcosa di poco più grave di scaramucce fra militanti avversi. Invece non s’era mai vista una violenza così estrema. O forse era contenuta “in potenza” nello spontaneismo armato degli anni Settanta? Ecco un intervento di una donna che quegli anni li ha vissuti, non da spettatrice ma da militante di Lotta Continua. (Redazione)
Si dicono antifascisti e continuano a farlo: anche dopo avere legato e massacrato un militante di Forza Nuova (Palermo), anche dopo aver imbottito di chiodi le bombe carta contro un poliziotto (Torino), anche dopo aver detto che i poliziotti devono morire (la professoressa “di lotta”, sempre Torino): ultimo episodio in ordine di tempo l’attivista di CasaPound aggredito a bastonate a Livorno. Episodi di gravità inaudita, di violenza forse nemmeno equiparabile a quella degli anni Settanta, quando pure i fronti erano contrapposti a suon di spranghe e P38. C’è un problema ed è un problema grave: i giornaloni non ostili al governo (mettiamola così) non registrano l’estrema gravità di quanto sta accadendo da parte degli autoproclamati antifascisti a danno di quelli che identificano come il nemico da abbattere col fucile (parole dette espressamente dalla succitata prof di Torino, basta ascoltare l’audio). O meglio, registrano la notizia come si trattasse di qualcosa di poco più grave di scaramucce fra militanti avversi. Invece non s’era mai vista una violenza così estrema. O forse era contenuta “in potenza” nello spontaneismo armato degli anni Settanta? Ecco un intervento di una donna che quegli anni li ha vissuti, non da spettatrice ma da militante di Lotta Continua. (Redazione)
Non ho mai rinnegato la mia militanza giovanile in Lotta Continua, la formazione più interessante del complesso arcipelago della sinistra extraparlamentare negli anni ’70.
Volente o nolente, ne reco le stimmate. Con euforico tormento. Ci si ubriacava di “luna, di vendetta e di guerra” , di “due anime e un sesso di ramo duro in cuore”, di un “è difficile capire se non hai capito già”.
Sempre a bordo delle liste di proscrizione del PCI : se sfottevi un celerino, era incidente probatorio. Kossiga agli Interni, Giorgiana Masi ad imbrattarsi di sangue e di bombolette indiane metropolitane. Il canoro Ti amo -Ti improvvisamente declinato in Ti sparo-Ti. Eravamo di una cattiveria “poetica”, assai poco terroristica. Iperbolica. L’unica clandestinità che passava il convento era quella intrattenuta con i Fiori rosa e di pesco di Lucio. Adulterio musicale custodito dal discreto, stridulo anfratto di un mangiadischi. E pensare che nemmeno Mogol era fascista. La devozione per Lenin non ammaliò mai Sofri. “Più che alla testa delle masse, la testa delle masse“, diceva. Gli scrissi un giorno dalla mia Sapri, oltre cent’anni dopo Pisacane, e mi ritrovai in prima pagina. Su Lotta Continua, giornale omonimo. Per comprarlo, frugavo ogni giorno nel borsellino di nonna Ernestina. Finché mio padre, vinto, non lo previde ufficialmente nel budget quotidiano. Antagonisti non elitari, o forse sì. Ragazzacci ebbri di operaismo lirico. Occupammo binari, strade, autostrade, ospedali. “Disoccupammo le strade dai sogni“.
Poi venne quell’umida primavera del’78, senza alghe in fiore, nella baia di Sapri. Aldo Moro non tornò a casa, nemmeno la sua scorta. La “geometrica potenza” di via Fani detonò nelle nostre anime concave. Dentro il ventre del mio mare campano. Piansi lacrime di marmo. A maggio, il 9 maggio, la morte smarrì la sua solennità dentro il portabagagli di una Renault, nel centro di Roma.
E tutto andò in pezzi. Inesorabilmente. Quel 9 maggio. Al ritorno da un viaggio in Toscana, scalai d’un fiato le rampe di salsedine e cercai l’abbraccio di mio padre perché lenisse i lividi del cuore. Tumefazione di anime ingerite in gola, a bordo di un vascello lacrimoso. Io e lui, improvvisamente coetanei, fratelli, complici e veglianti le spoglie di un sogno dilaniato. “Né con lo Stato né con le Br“.
Così, in corteo, una mattina di maggio, senz’alghe appena in fiore e senza promesse d’estate incipiente, o suoni rauche di chitarre che virano a rosse lune. Tramonta un decennio di empiti e furori, di passioni scandite da collettive partiture musicali. Tramonta e declina dal cielo lungo l’asfalto molle e languido del mare, come residuo brandello di un fuoco d’artificio in disarmo. Bagliore agonizzante che la baia trattiene nel suo grembo.
Prima di quel portabagagli in via Caetani, che esemplificò plasticamente le nostre diffuse impotenze, avevamo praticato alla stregua di un elettrizzante rito dionisiaco, il fervore “antifascista”, quasi a voler significare un’alterità irriducibile al nostro stigma. Vietato parlare con i ragazzi del Fronte della Gioventù. Intrattenevamo con “il diavolo” soltanto espresse, sulfuree contrarietà. Mai dialogate. Interdetta, all’epoca, ogni interlocuzione. E se violavi la regola, le prendevi dai tuoi. E quando mia sorella s’innamorò platonicamente, oltre ogni ragionevole prudenza “militante”, di Tiziano, giovane veronese, di provata fede mussoliniana, fu regolarmente “processata” nella sede di Radio Pisacane, media per eccellenza della controinformazione della sinistra eterodossa. Tra i suoi pubblici accusatori, io fui la più feroce. Non le rivolsi la parola per un mese, nonostante dividessimo la stessa cameretta, addobbata con i poster di Ho Chi Minh e di Alain Delon. Non le parlai finché non ebbe dismesso quell’amore “empio”.
Sì, era un altro tempo. Delle visioni del mondo contrapposte: internazionalismo e patriottismo collidevano fragorosamente. E l’internazionalismo non somigliava affatto al globalismo di questa feroce attualità. La febbricitante, simultanea irruzione di milioni di sogni in tutto il mondo negava l’individuo-nazione. La tradizione comunitaria e di famiglia, stricto sensu, era resistita dall’insorgere di un sentimento che interrompeva il quieto incedere delle consuetudini. Ci si scontrava sulla destinazione di senso delle nostre vite. Il dopoguerra e le sue ferite non erano ancora il “paleolitico”. Ed il mondo diviso in blocchi, nelle due aree d’influenza, una contiguità temporale.
Non solo. Il ’68 aveva già, da un decennio, disintegrato il totem dell’autorità. L’antifascismo, dunque, era oltraggio al senso dell’ordine costituito, fiotto di sana asserzione delle libertà. Eppure, nonostante ciò, mi pento dell’odio inflitto e patito in quei giorni. Delle botte date e ricevute.
Mi pento della distanza intercorsa, per troppo tempo, tra il mio sguardo e quello di un amico come Pippo Florenzano, reo di una fede opposta alla mia. Oggi, dentro la miserevole parodia di anni incandescenti, detenuti ormai dentro un archivio storico, dirsi “antifascisti” è uno stucchevole pleonasmo. Una ridondanza patetica. Perché il nemico non è più dove lo lasciammo : è migrato altrove. Ha volti imperscrutabili, compostezze algebriche. Asettiche. Veste la mistica del danaro. Non è più Tiziano, il riccioluto ganzo di mia sorella.
LEGGI ANCHE: Sono fuori dal tempo gli “utili idioti” dell’antifa