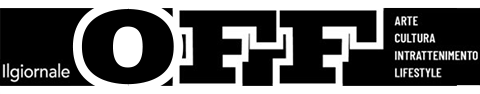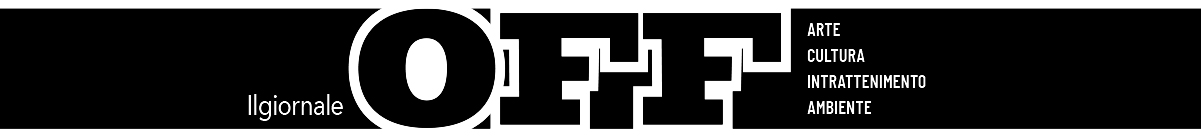L’8 giugno del 1768 gli avventori della Locanda Grande di Trieste furono svegliati da alcuni strani rumori provenienti da una delle stanze del locale. Andrea Hartaber, cameriere di servizio, accorso sul posto dal quale giungeva quell’inconsueto frastuono, fu spintonato da un individuo che scappò via. Ripresosi, Hartaber trovò un cliente disteso a terra in una pozza di sangue. Mandato a chiamare un medico, si capì che non c’era nulla da fare. L’uomo, però, prima di spirare, fece in tempo a confessare che il suo assassino era l’uomo della stanza accanto. Si trattava di tale Francesco Arcangeli, un cuoco toscano pregiudicato, che sarà arrestato e condannato a morte. La vittima, invece, era nientemeno che Johann Joachim Winckelmann, storico dell’arte, archeologo, tra i fondatori del Neoclassicimo. Strana fine per l’uomo che, da figlio di ciabattino, era divenuto soprintendente alle antichità di Roma, segretario della Biblioteca Pontificia, antiquario della Camera Apostolica.
Si è sempre liquidato questo delitto come un furto finito male o come un rapporto omosessuale degenerato. Arcangeli e Winckelmann si erano conosciuti da alcuni giorni ed erano divenuti- come racconterà il proprietario dell’osteria- “amicissimi”, di “un’amicizia particolare” come scriveranno Montanelli e Gervaso. Ma, a duecentocinquanta anni da quel giorno, Paola Bonifacio, storica dell’arte e conservatrice della pinacoteca Alberto Martini di Oderzo, nel suo Il delitto Winckelmann (editore Metamorfosi, 152 pagine, euro 11,90), a cui è seguito il documentario In morte di un archeologo, ci fornisce un quadro molto più complesso e suggestivo che si trova in linea con alcune conclusioni a cui sono arrivati studiosi ed esperti nel corso dell’appena concluso convegno internazionale dedicato al Wickelmann “privato” organizzato dall’università di Trieste.
Intanto, Bonifacio, cosa ci faceva Winckelmann a Trieste?
Era in viaggio da Vienna a Roma, e per raggiungere la Città Eterna era in attesa di imbarcarsi per Ancona.
Sappiamo chi materialmente uccise l’archeologo, meno chiare sono le motivazioni del delitto…
Arcangeli, durante il processo, ammise che, se avesse voluto impossessarsi dei beni dell’archeologo, avrebbe potuto rubarli quando avesse voluto, vista la contiguità tra le due camere. Perché ucciderlo allora? Tra l’altro, il delitto non è affatto improvviso ma accuratamente progettato: l’assassino, infatti, si era procurato con ampio anticipo lo spago, che aveva predisposto a nodo scorsoio, e il coltello.

Durante il processo, inoltre, l’Arcangeli dimostrò di sapere molte cose su Winckelmann…
Reiteratamente, rivelò dettagli piuttosto importanti ma curiosamente non degnati della minima attenzione da parte degli inquirenti, come l’ incontro informale di Winckelmann con Maria Teresa e il ministro Wenzel Anton von Kaunitz. Intanto, da Vienna e da Roma ci furono forti pressioni per chiudere la questione ed avere i beni della vittima, tra cui alcuni documenti di cui non è dato conoscere il contenuto.
Qual è la sua ipotesi?
Winckelmann, probabilmente, era finito in un gioco molto più grande di lui. Questi documenti richiesti e poi spariti ci dimostrano che, probabilmente, l’archeologo stava facendo le veci di messaggero tra Roma e Vienna, tra la Santa Sede e l’Impero.
Riguardo a cosa?
Alla soppressione della Compagnia di Gesù, invisa a Giuseppe II (che mirava ad incamerarne le enormi fortune) ma ben vista dall’imperatrice ben consapevole che l’efficiente organizzazione del suo sterminato Impero era garantita, in considerevole parte, dai padri gesuiti. E chi meglio dello storico tedesco, convertito al cattolicesimo, per fare da tramite per una questione così spinosa?