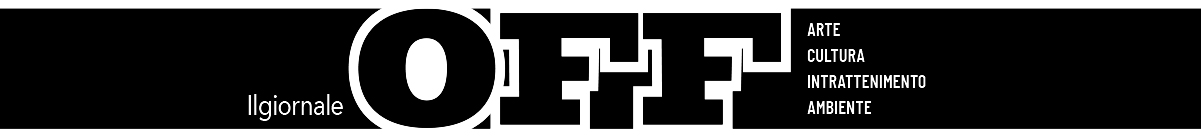Nevrosi, fobie e ossessioni figurano sempre più spesso come il filo conduttore di tanto cinema e serie televisive. Uno dei primi a fare della psicanalisi l’oggetto/soggetto della pellicola è il regista, attore e scrittore newyorkese Woody Allen. In tale ambito, la riflessione non sosta sulle indiscutibili abilità registiche del cineasta, quanto sulla disinvoltura adoperata nello sdoganare dapprima e dissacrare poi, l’uso o abuso che si fa con l’indagatore dell’inconscio. All’interno di numerose pellicole, il regista, oltre a beffarsi del paziente, sovente rappresentato da se stesso, si dileggia nella derisione della figura sin troppo osannata del terapeuta. La sua opera si snoda in una sottile profanazione, dove il mito freudiano finisce per umanizzarsi nelle tare umane. Pertanto non Diane Keaton, neppure Mia Farrow e ancor meno Scarlett Johnasson descrivono l’assunto centrale dei suoi film, ma un’unica figura ruba la scena: il santone depredato di solennità nell’immagine dello psicanalista. Frequentazione tanto ostentata dal popolo americano, quanto pudicamente taciuta da quello nostrano. Woody Allen veste gli abiti del reporter corrosivo, sardonico e comico, immergendosi nelle contraddizioni della società a stelle e strisce, dagli anni ’70 a oggi.
 Ancora in America, ma nello specifico alla luce dei pensieri nell’ideatore della serie David Chase, torna a emergere la figura della psicanalista freudiana. La catena di eventi, che lega un boss italo-americano al lavoro faticoso della terapeuta, è nel telefilm I Soprano. Il successo, certamente più statunitense che italiano, si lega a un potente dissidio interiore del protagonista: un contrasto tra l’uomo di famiglia e quello del capo della malavita nel New Jersey. In tale altalena di emozioni, difformi quanto distruttive, sino a trascinarlo nel fuoco di violenti attacchi di panico, l’ultimo degli orgogliosi, si vede costretto a rivolgersi al cospetto di una professionista del settore. Tony Soprano, all’interno di un’inadeguatezza tutta tra l’uomo e il maschio, con fatica si abbandona nell’ammissione della devastazione provocata dal male oscuro: la depressione. Quella dei Soprano, come molte altre trattate da Woody Allen, rappresenta una famiglia disfunzionale che vive nella presunta condizione di normalità. Ammesso che sia semplice scovarne il confine. La crepa dalla quale penetra una flebile luce è in una debole, seppur rumorosa, consapevolezza, avvertita dal corpo, ma risuonata in un campanello tutto mentale. In Italia, la serie fatica a decollare quanto meriterebbe, poiché viene riduttivamente interpretata solo come un esteso luogo comune dell’italiano mafia e spaghetti. In realtà l’opera è molto più importante nella misura in cui mostra le fragilità che albergano negli esseri umani. Laddove per fragilità non si esclude paradossalmente anche una certa spietatezza. La stessa madre del protagonista, Livia, sintetizza in un’affermazione definitiva il pensiero più diffuso: “La psicanalisi nella comunità italiana è rifiutata”.
Ancora in America, ma nello specifico alla luce dei pensieri nell’ideatore della serie David Chase, torna a emergere la figura della psicanalista freudiana. La catena di eventi, che lega un boss italo-americano al lavoro faticoso della terapeuta, è nel telefilm I Soprano. Il successo, certamente più statunitense che italiano, si lega a un potente dissidio interiore del protagonista: un contrasto tra l’uomo di famiglia e quello del capo della malavita nel New Jersey. In tale altalena di emozioni, difformi quanto distruttive, sino a trascinarlo nel fuoco di violenti attacchi di panico, l’ultimo degli orgogliosi, si vede costretto a rivolgersi al cospetto di una professionista del settore. Tony Soprano, all’interno di un’inadeguatezza tutta tra l’uomo e il maschio, con fatica si abbandona nell’ammissione della devastazione provocata dal male oscuro: la depressione. Quella dei Soprano, come molte altre trattate da Woody Allen, rappresenta una famiglia disfunzionale che vive nella presunta condizione di normalità. Ammesso che sia semplice scovarne il confine. La crepa dalla quale penetra una flebile luce è in una debole, seppur rumorosa, consapevolezza, avvertita dal corpo, ma risuonata in un campanello tutto mentale. In Italia, la serie fatica a decollare quanto meriterebbe, poiché viene riduttivamente interpretata solo come un esteso luogo comune dell’italiano mafia e spaghetti. In realtà l’opera è molto più importante nella misura in cui mostra le fragilità che albergano negli esseri umani. Laddove per fragilità non si esclude paradossalmente anche una certa spietatezza. La stessa madre del protagonista, Livia, sintetizza in un’affermazione definitiva il pensiero più diffuso: “La psicanalisi nella comunità italiana è rifiutata”.
In patria, diversi registi si sono mossi in questo campo, spesso minato, mediante atteggiamenti diversi. Nell’adottamento di una chiave ironica, il regista Francesco Nuti, attraverso il suo celebre Caruso Paskoski, mostra una galleria che scorre velocemente in un’umanità disorientata. Temi complessi come disturbi mentali o difficili latenze, vengono affrontati in un clima lieve e delicato. Non si aggrappa al tono dissacrante di Woody Allen e ancor meno all’introspezione posta in scena da Chase, ma predilige un tono, che nell’ilarità, non sottrae importanza alla materia trattata. Diversamente, in un ritmo balenante da commedia, conferisce verità alla finzione. Il mastice tra i due registi e l’ideatore della serie è la sfera psicanalitica nella cognizione che taluni disagi, presumibilmente, richiedono l’intervento di un professionista.
La materia divide, oscillando tra scettici e devoti, ma il dato innegabile ripiega su un’immagine ormai desueta: la chaise longue. La greppina che occupa lo spazio dello psicanalista freudiano o junghiano, alla maniera di un elegante “vomitatoio”. Contenitore dentro il quale risulta superato sostare, poiché definitivamente surrogato dall’avvento del social network. Il tema potrebbe risultare abusato per le innumerevoli discussioni che occupano gran parte dei media, ma il sistema social nel riavvolgersi sempre più spesso in una totale assenza di tutela, finanche per i più piccoli, sembra disinteressarsi ad arginare la materia magmatica “livor-fatale”. Che il sintomo si sia fatto malattia è abbondantemente testimoniato, nei casi più gravi, dal fenomeno suicidale. Nelle altre situazioni, sempre e comunque al limite, l’asserzione è nel malessere di chi subisce, ma oltremodo di chi colpisce. Un tempo, neanche tanto lontano, il social figurava come l’allegoria di una piazzetta dove poter ritrovare vecchi amici, ascoltare una canzone, improvvisare due passi di danza sino, in un colpo tutto di destino, incontrare un amore. La passione di un giorno, di un mese o di una vita poco importa, ma la piazzetta si animava anche in quel corteggiamento ormai così lontano. Oggi, quel piccolo spazio si è fatto città anonima con al centro un gigantesco ring. Spazio nel quale ci si avvicenda nella figura della vittima e in quella del carnefice. La chaise longue è rimasta impolverata nell’alloggio che circoscriveva quel piccolo slargo, ma il ring si è fatto potente e gigante, quanto la sua invisibilità. Un nemico occulto tutto di livore, rabbia e frustrazione dove il social network si riassume nella meschinità di un mostruoso “vomitatoio”.
maniera di un elegante “vomitatoio”. Contenitore dentro il quale risulta superato sostare, poiché definitivamente surrogato dall’avvento del social network. Il tema potrebbe risultare abusato per le innumerevoli discussioni che occupano gran parte dei media, ma il sistema social nel riavvolgersi sempre più spesso in una totale assenza di tutela, finanche per i più piccoli, sembra disinteressarsi ad arginare la materia magmatica “livor-fatale”. Che il sintomo si sia fatto malattia è abbondantemente testimoniato, nei casi più gravi, dal fenomeno suicidale. Nelle altre situazioni, sempre e comunque al limite, l’asserzione è nel malessere di chi subisce, ma oltremodo di chi colpisce. Un tempo, neanche tanto lontano, il social figurava come l’allegoria di una piazzetta dove poter ritrovare vecchi amici, ascoltare una canzone, improvvisare due passi di danza sino, in un colpo tutto di destino, incontrare un amore. La passione di un giorno, di un mese o di una vita poco importa, ma la piazzetta si animava anche in quel corteggiamento ormai così lontano. Oggi, quel piccolo spazio si è fatto città anonima con al centro un gigantesco ring. Spazio nel quale ci si avvicenda nella figura della vittima e in quella del carnefice. La chaise longue è rimasta impolverata nell’alloggio che circoscriveva quel piccolo slargo, ma il ring si è fatto potente e gigante, quanto la sua invisibilità. Un nemico occulto tutto di livore, rabbia e frustrazione dove il social network si riassume nella meschinità di un mostruoso “vomitatoio”.
Non si invoca uno psicanalista, un prete o un esorcista, ci si appella (forse inutilmente) a quella piccola parte di consapevolezza o forse di buon senso di piegare uno strumento alla costruzione e non alla distruzione a oltranza. Le parole non sono mai solo parole. Le espressioni possono farsi pietre per alcuni e lapidazione per altri. Non si anela neppure a un nostalgico ritorno all’allegoria della piazzetta, ma quantomeno a prendere le distanze da un vortice che inghiotte tutti indistintamente.
“Con le parole uno non sta mai abbastanza in guardia, hanno un’aria di niente le parole, non un’aria pericolosa di sicuro, piuttosto dei venticelli, piccoli suoni buccali, né caldi né freddi, e facilmente assorbiti quando arrivano attraverso le orecchie all’enorme noia grigio molle del cervello. Uno non fa attenzione a loro, alle parole, e la disgrazia arriva.”
Louis-Ferdinand Céline – Viaggio al termine della notte