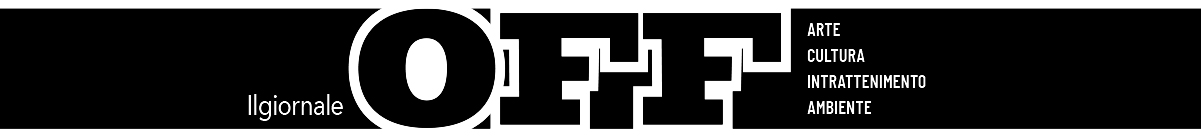Se avete letto Le città invisibili di Italo Calvino avete già un’idea dell’universo immaginifico dell’artista milanese Fabio Giampietro (classe ’74). Se invece non avete avuto trascorsi col romanzo del succitato scrittore, non dovrete fare altro che visitare la Sala degli Arazzi di Palazzo Reale a Milano in un giorno compreso fra giovedì 14 a domenica 17 aprile e prepararvi ad assistere a Hyper planes of simultaneity, esperienza interattiva di Fabio Giampietro: città “incompossibili” su un’enorme tela di dieci metri, con un’aberrazione della prospettiva attraverso un particolare cono ottico, quello dell’Oculus Rift, visore 3D che vi porterà all’interno di una realtà virtuale. Guardando l’opera di Giampietro con questa estensione della nostra percezione sapremo cosa si prova ad assistere alla sua “esplosione” dalla tela e al suo “assorbimento” dell’intero ambiente, sperimentando un’alterazione della percezione dello spazio espositivo e una trasposizione in una dimensione onirica. Roba molto psichedelica, insomma, torna alla mente un altro scrittore, l’Aldous Huxley di Doors of perception e così il Palazzo Reale milanese diventa il Palazzo Irreale. Ne parliamo con Fabio Giampietro nel suo studio milanese, in mezzo a robotini e videogiochi da bar degli anni ’80, collezioni di Urania, Marlboro nere e vino rosso e, last but not least, vertigini cittadine dipinte.
Caro Fabio, partiamo dall’inizio ma non troppo: la prima volta che ho sentito parlare del tuo progetto Hyperplanes of simultaneity, quando sono passato a trovarti nel bellissimo teatro delle marionette dove stavi lavorando a una tela di dieci metri: avevi approfittato dell’occasione per farmi provare l’Oculus e guardando i tuoi quadri con quel “prolungamento” della mia percezione visiva mi sembrava davvero di precipitare nel vuoto dal cornicione di un grattacielo. Come è nato questo progetto? Come hai organizzato il lavoro fra il teatro e il tuo studio “fisso” di Milano? Come hai lavorato? Hai collaborato anche con altre persone per realizzare questo progetto?
Il progetto è nato e si è sviluppato con l’amico di sempre, Alessio de Vecchi, digital artist e cervello in fuga che, reduce da una decina di anni di New York, è oggi un felice cittadino di Tokyo. Abbiamo cercato negli anni un territorio di collaborazione e l’avvento di questi dispositivi ha creato l’opportunità. Sono partito dal linguaggio pittorico figurativo tradizionale seguendo il sogno di Lucio Fontana di andare oltre lo spazio della tela, cosa che fece iconicamente con la sua serie delle Attese, sperimentando con le nuove tecnologie per creare varchi dimensionali sulle realtà parallele. E’ da qui che nasce il progetto Hyperplanes of Simultaneity. Un nome che sembra rubato alla fantascienza e che rimanda alla sfera semantica delle nuove teorie della fisica moderna. Il tempo non è considerato più come un fiume che scorre, ma secondo la teoria del block universe i momenti di passato presente e futuro coesistono. Le nuove tecnologie permettono un’esperienza virtuale molto convincente rispetto al passato: siamo in un inizio millennio molto eccitante per chi come me ha vissuto l’adolescenza tra gli ‘80 e i ‘90, molto dell’immaginario fantascientifico di quegli anni è diventato reale e quotidiano. Il mio obiettivo è stato dunque di provare a creare un dialogo tra passato e futuro, tra la tela dipinta e la sua versione immersivo/virtuale, permettendo a chi guarda di condividere il mio universo immaginifico (in questo caso pittorico). Con Alessio abbiamo cercato di trasferire la sensazione della tela, la matericità del colore, la trama del tessuto dipinto e il gesto cercando di limitare il più possibile la percezione di essere in una illusione digitale. Il teatro era frequentato in quel periodo da un ben nutrito gruppo di artisti sperimentatori, è li che è nata l’installazione del padiglione del Vaticano di Expo. E’ un posto magico che mi ha permesso di dipingere la grande tela che costituisce attualmente l’opera principale di Hyperplanes: uno tsunami metromorfico di dieci metri montato su un telaio curvo, come un abbraccio, ad invitare chi guarda ad entrare nel quadro.
E ora andiamo veramente all’inizio: quali sono state le suggestioni del piccolo Fabio, che dall’infanzia l’hanno portato a questo tipo di estetica molto particolare (il classico vertigo, il punto di vista dall’immensità di altezze urbane che grattano il cielo)? So che, nel mondo là fuori, ci sono dei fuori di testa che con la GoPro ci mozzano il fiato rendendoci partecipi delle loro acrobazie sui cantieri cittadini a centinaia di metri dalla terra…
Frugando tra i ricordi posso dirti che il piccolo Fabio, a parte avere una madre che soffriva tremendamente di vertigini, aveva un cervello ancora libero dal vortice. La suggestione ossessione è arrivata più tardi ed è il frutto più di un percorso pittorico che di un vissuto personale. I soggetti dei miei quadri mi hanno dato modo di avere a che fare con qualcuno di quei fuori di testa: sono salito in cima ai grattacieli di Toronto con un gruppo di questi rooftoppers, ma devo dire che provo più vertigine nei due metri sottoterra del mio studio.

Il tuo lavoro d’arte è anche “sociale”? Mi rifiuto radicalmente di credere che sia solo divertissement!: il coinvolgimento del pubblico è ovviamente una parte integrante del tuo lavoro e l’hai dimostrato in altre occasioni, come l’installazione dell’Aletide in cui il pubblico, uno a uno, era invitato a dondolarsi su una vera altalena posta di fronte a una tua “vertigine”, il tutto collegato a un sistema software che faceva provare la sensazione di entrare veramente nel tuo quadro…
Fare arte è comunicare e condividere, sono assolutamente attento al dialogo tra l’opera e chi la guarda e se chi osserva si diverte anche è fatta. Il messaggio più intimo veicolato dall’opera arriva dopo, lavora su un altro livello, più inconscio. La “socialità” è importantissima anche nel processo di realizzazione, L’altalena ad esempio che tu hai citato nasce proprio da un lavoro di confronto e collaborazione con un musicista, un ingegnere ed una visual artist.
L’attrazione per i luoghi abbandonati (prevalentemente industriali) in pittura fino a poco tempo fa andava via come il pane, ora ha rotto le balle. Ma tu dimmi qualcosa sulla tua fascinazione per i luna park abbandonati: se ne trovi uno tipo Consonno, la città fantasma che si trova a Lecco, che fai? Te lo chiedo perché in-una vita-precedente-ma-non-troppo il luna park era (è?) il tuo tema prediletto. O forse in ossequio a Bret Easton Ellis nel tuo caso potremmo dire Lunar Park?
Ognuno dentro di sé ha un Luna Park abbandonato: è un contenitore di simboli che ho utilizzato negli anni come spazio di riflessione su diversi temi. Le imponenti strutture di ferro dei luna park affiancate agli scheletri dei dirigibili utilizzati come bombardieri nella Prima Guerra Mondiale, la grande ruota panoramica ferma come un grande orologio di un campanile dopo una catastrofe, una bambina, persa ma perfettamente a suo agio nel suo giocare con la morte o con il buio, la stessa bambina immobile che fissa il palco di un teatrino delle marionette completamente vuoto: sono tutte figure che vorrei stimolassero a non cedere alle paure e essere sempre consapevoli che quel momento magico in cui si è creata la nostra immagine del mondo esiste ancora. La possibilità di dargli un altro colore, un altro nome e un’altra forma ci accompagna per tutta la vita: non a caso proprio il primo Luna Park è stato utilizzato come territorio di sperimentazione per la città nuova, la città in verticale, New York. Detto questo, tra i luoghi dismessi i luna park abbandonati sono quelli che mi attraggono di più; ne ho visitati parecchi, Consonno fino alla nausea da ragazzo, lo SpreePark, Coney Island prima della sua riapertura nei primi anni del 2000, il LunEur, Palos Verdes…Non ho ancora visitato Greenland, ma lo farò in questi giorni. E mi piacerebbe vedere la ruota di Pripyat dal vivo.
Il fatto che i tuoi quadri escano dalla bidimesionalità è un po’ una costante: grazie alla collaborazione con la costumista Marzia Paparini un tuo quadro è addirittura diventato un vero e proprio vestito, il Vertigo Dress. Ancora una volta un’opera di Giampietro è fruibile e, in questo caso, addirittura indossabile. Vuoi parlarcene?
E’ un’esperienza di qualche anno fa. Io e Marzia ci siamo conosciuti perché suo padre le regalò una mia grande tela, aveva in programma una sfilata a Hollywood in occasione di una sorta di Fashion Week per costumisti del cinema, del teatro e dello spettacolo. Mi ha coinvolto perché pensava di presentare insieme alle sue creazioni qualcosa di diverso, di quello spettacolare che piace molto nella West Coast. Nel giro di qualche mese sono nati i due Vertigo Dress, abiti scultura dipinti ad olio che sono stati utilizzati come immagine dell’intera manifestazione l’anno successivo.

Viaggi spesso e non necessariamente solo in posti da borghesucci tipo Londra o Parigi: per un artista tutte le esperienze sono importanti, quanto incide il viaggio sul lavoro d’arte di Giampietro Fabio?
Adoro viaggiare, non starei mai fermo, mi piacerebbe essere la mia casa, adoro anche Londra e Parigi per la verità, più che essere ispirato dal nuovo penso che stimoli un processo di rafforzamento della mia identità artistica. Attraverso il confronto sono più consapevole di me stesso, di quello che faccio e di quello che voglio dire agli altri.
Cos’è il successo, per te?
Il successo è la capacità selettiva di resistere all’oblio. Nell’arte oggi è difficile slegare il successo dalla popolarità , è spesso il mercato che detta le regole del gioco. L’arte non è un torneo di scacchi in cui vince chi sa giocare meglio e non ci sono sponsor.