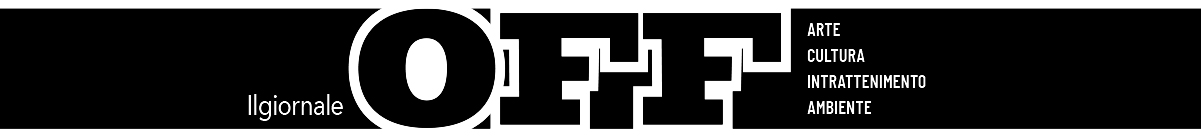La questione dell’iconoclastia innerva la storia delle religioni fin dagli albori. I tre monoteismi, ponendosi in antitesi al paganesimo che è eminentemente iconofilo, hanno dovuto affrontare alla radice il problema della raffigurazione della divinità: essendo il sommo trascendente, dio non può essere, o non deve essere rappresentato (talvolta neppure per mezzo della parola) poiché ogni determinazione sarebbe una limitazione della sua estensione, una definizione temporale della sua eternità. L’Ebraismo e l’Islamismo risolvono in nuce il problema vietando ogni forma di figura, mentre nel Cristianesimo il dibattito è proseguito per secoli. L’iconodulia, che nella cristianità alla fine ha prevalso, si è accreditata a partire da radici certamente politeiste sulla base delle quali è stata ammessa la venerazione di divinità minori o intermedie tra l’uomo e dio, angeli e santi, le quali andavano a sostituire o a perpetrare altrettante forme primordiali di religiosità legate ai lari e ai penati (i demoni della casa), i quali a loro volta richiamavano infine forme animistiche, ancora più diacronicamente risalenti, in cui l’oggetto del defunto o che ricorda il defunto, facendosi feticcio, si carica di aspetti sacri, quasi magici.
E’ chiaro che questa tensione rappresentativa tende a generare idolatria, cioè devianza dalla divinità che viene sostituita da immagini, contemplate in sua vece e in sua assenza. Ma nello stesso tempo, se volessimo fare un discorso laico, almeno in Occidente, l’iconodulia ha permesso l’apoteosi della pittura figurativa di matrice cristiana. Nell’Oriente, le cose sono invece andate diversamente, poiché ha resistito, da un lato, la tentazione iconoclasta e dall’altro, in contrapposizione, si è cristallizzata una sorta di iconofilia, sublimata nella ripetizione del modello, così come accade nella tradizione ortodossa.
La ricerca di Svitlana Grebenyuk, che proviene per biografia ed educazione artistica proprio dal mondo dell’iconodulia russa, si innerva al crocevia di questa disputa che diventa ancor più esiziale nel padiglione della Repubblica Araba Siriana della Biennale 2015, essendo la Siria terra di confine di una secolare battaglia; prima ancora che imperasse definitivamente il credo dell’Islam, già tra il V e il VI secolo dopo Cristo, l’eresia dei pauliciani predicava, in quelle terre desertiche, il digiuno, l’astensione forzata dalle immagini.
Certo, l’arte della Grebenyuk è eminentemente contemporanea, non paga dazio alle cristallizzazioni stilistiche dell’iconofilia ortodossa; neppure è succube di una forzata iconoclastia, tipica anche oggi di certe teorie novecentesche le quali, non più per motivi religiosi semmai per questioni programmatiche, predicano il concettuale o l’astrattismo come unici stili della modernità. Ciò nonostante i suoi lavori, tra apparire e sparire, richiamano lo spirito di questa millenaria dicotomia.
Nel lavoro di Svitlana quello che resta dell’icona è infatti l’impronta, il doppio svanente, frutto della tecnica del monotipo per cui l’immagine è precisamente acheropita, cioè non prodotta da mano umana, e in questo quasi divina, essendo calco e – si badi – non copia dell’originale. Nello stampo si perde la linea, ma anche la massa pittorica si fa evanescente, tende a restare solo il ricordo, la reminiscenza dell’immagine. E anche la conoscenza del reale si fa labile essendo l’aspetto mimetico frustrato, immolato sull’altare del riflesso, che ripropone ingannando l’immagine e se ne allontana per sfasatura e che ci impone una continua messa a fuoco sia oculare che interiore, uno sforzo per riappropriarci della primordiale forma.
Una dissoluzione che era già iniziata quando la Grebenyuk era passata da un colorismo violento, una sorta di neoprimativismo molto legato alla tradizione della sua patria, a una rarefazione in cui i ritratti in bianco e nero perdevano fisionomia e connotati, restando quasi solo esclusivamente linea esterna. Fino all’estrema consunzione, nel periodo giusto precedente a questo lavoro, in cui la serie delle icone prefigurava l’ulteriore passo verso una sorta di informale.
Pur aderendo a questo processo di dematerializzazione, nell’istallazione Friends of God, viene comunque esaltata una teoria di santi, o di amici di Dio, o di “giusti” secondo la tradizione ebraica, o di quelli che nell’Islam vengono definiti “wali” (per esempio i maestri di alcune comunità mistiche sufi) e di cui è permessa, a secondo dai paesi, una forma di rispetto, di residuale venerazione di matrice propriamente popolare.
Di fatto, al di là dei santi, in tutte e tre le religioni del Libro esistono comunque sostanze-essenze intermedie tra l’uomo e Dio: gli angeli, per esempio, che acquistano nell’una e nell’altra, consistenza diversa, benevola o più indifferente nei confronti dell’umanità, angeli raccolti in schiere e troni e gerarchie a seconda della tradizione, messaggeri alati del verbo divino, bellissimi, frutto della luce, simbolo della potestà divina.
Allo stesso modo, le non-più-icone della Grebenyuk, le quali svaporano modelli riconoscibili della pittura rinascimentale, assumono i connotati quasi di ex voto, vuoi per la forma vuoi per il carattere sacro, simili a pinakes (i quadretti votivi del mondo antico greco), sui quali la stampigliatura della divinità si fa metafora di una possibile intermediazione tra uomo e dio, a mo’ di preghiera, attraverso la semplice ripetizione della linea. D’altronde la non raffigurazione di Dio, è sostituita nelle culture iconoclaste dal fregio, dalla calligrafia, che è parola più che figura, verbo e non icona, mantra e non visione: una meta a cui tende, nella ripetizione arabescata dello stesso segno per sessanta volte, il lavoro presentato al padiglione siriano la cui essenza, percepita al primo sguardo nel totale, è quella del verso di un tappeto in cui vediamo i nodi e in traluce il modello, non del retto di cui non presagiamo la forma compiuta.
______
Commissario: Christian Maretti.
Curatore: Duccio Trombadori.