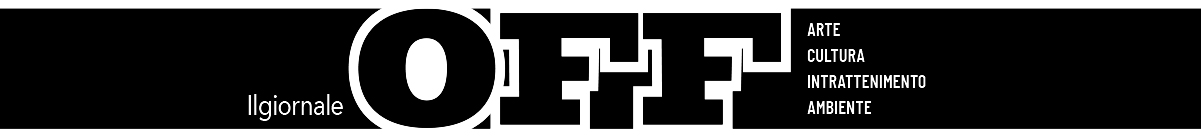Il critico contemporaneo cool si comporta come l’entomologo innamorandosi del proprio oggetto di studio. L’entomologo è ossessionato dalla tassonomia con cui classificare blatte e coleotteri, si entusiasma dei colori del carapace o della livrea, magnifica le doti motorie dell’animaletto, la furbizia nella ricerca del cibo, o i riti di accoppiamento e a nulla vale far notare che è pur sempre uno scarafaggio, ti squadrerà stupito della poca sensibilità di fronte a quella stupefacente porzione di creato. A poco varrà sostenere la bruttezza dell’insetto, al fuoco della lente, tutto il mondo si riduce a quel punctum.
Così il curator o il critico o lo storico dell’arte o lo specialista non vedono altro che l’oggetto del loro studio e anche la cosa più immonda trova un significato nel prima, perché è chiaro a chiunque che non è stato possibile passare dalla bellezza dell’arte della tradizione all’insulsaggine dell’arte nata morta di colpo, semmai è servito uno slittamento, una lunga catena di cause ed effetti a cui ci si appiglia quando si deve difendere l’insensato di un’opera concettuale. Un ritratto prodotto col sangue dell’artista medesimo ha come antefatto la merda d’artista, e la merda d’artista a sua volta il discorso sulla cultura pop di Andy Warhol, e la zuppa Campbell di Warhol trova sostegno nei ready made di Marcel Duchamp, e l’orinatoio di Duchamp sul fatto che le avanguardie hanno fatto bene a rompere con la tradizione del pittorico che in quel momento ci voleva. Ecco: ogni prodotto insensato dell’arte contemporanea ha una sua giustificazione che si regge solida dal 1917 in poi, al pari di un castello di carte si sostiene finché qualcuno toglierà il primo mattoncino.
Lo spiega il filosofo Roger Scruton: “Quanto all’ipotesi che esista una critica in cerca di valori oggettivi e dei monumenti duraturi innalzati dallo spirito umano, viene liquidata senza esitazione come discendente da una concezione dell’opera d’arte che è stata eliminata senza tanti complimenti nello scarico della ‘fontana’ di Duchamp. L’argomentazione è facilmente condivisibile, in quanto dà l’impressione di emancipare le persone dal fardello della cultura, sostenendo che tutti questi venerabili capolavori possono essere impunemente ignorati, che le telenovelas sono ‘valide’ quanto lo è Shakespeare, e che i Radiohead sono al pari di Brahms, dal momento che nulla è meglio di qualsiasi cosa e che tutte le rivendicazioni di valore estetico sono vuote. Dunque l’argomentazione è in sintonia con le forme del relativismo culturale oggi di moda”.
Più in generale, il problema non è l’arte contemporanea, semmai quello che con un neologismo potremmo definire “sgunz”, il quale si fa arte. A pensarci bene, tutta l’arte è stata contemporanea almeno una volta e molta dell’antica è più contemporanea di quella nuovissima. D’altronde l’arte antica che è sopravvissuta al tempo, per quanto riguarda la fruizione, è certamente contemporanea. Dunque tutta l’arte che abbiamo la possibilità di vedere ci è contemporanea. Così ragionando, possiamo bene realizzare cosa è arte, quali sono i valori che la sorreggono, perché una cosa vada considerata arte e una cosa no: l’immenso millenario giacimento su cui ci reggiamo è un terreno solido da cui non dovremmo prescindere. Al di là degli stili, delle rotture, delle provocazioni, dei ritorni – è chiaro che non c’è evoluzione nella storia dell’arte, semmai un approssimarsi a quello che si vuole dire in un certo momento di una certa epoca – la congerie di cose e oggetti e monumenti che si sono accumulati nei secoli ci fornisce un perimetro di senso. Complicato codificare questo senso in modo compiuto, ma sufficiente per farci dedurre che l’arte più o meno è sempre stata collegata al bello, al fatto bene, alla rappresentazione, alla comunicazione, al trascendente (perfino quando essa rappresentava il brutto e l’orrendo). Di fatto, un oggetto o un edificio assurgeva a opera d’arte quando se ne riconosceva la bellezza, la fattura, la forma, il pensiero da cui era scaturito, oppure la capacità cosciente di comunicare un pensiero, o farci avvicinare al divino.
Ebbene, considerando in tutte le sue pur varie eccezioni l’apparato normativo che è tutta la storia dell’arte fino ad ora, se una cosa è brutta in quanto mal fatta, non vuole comunicare nulla, perché dovrebbe essere considerata arte? E perché in verità viene considerata arte? Domande a cui non è facile rispondere e qualora ci si tentasse rischieremmo di essere derisi, poiché la non-arte di oggi si basa su un sistema ideologico e di potere radicato che non ammette cedimenti. Dato che alla fine la verità prevale sulla menzogna e la realtà sull’ideologia, lo sforzo di fronteggiare la non-arte potrebbe perfino essere sovraordinato rispetto al risultato che ci prefiggiamo, essendo il tempo un buon giudice, e in un prossimo futuro tutte le stravaganze nuovissime avranno il sapore stantio delle collezioni di stranezze che i nobili dei secoli passati raccoglievano nelle wunderkammer e ora ci appaiono per quel che sono: animali esotici impagliati, feti sotto formaldeide, corni e teschi di bestie mitologiche mai esistite, meccanismi e macchine per stupire un pubblico incolto, paccottiglia priva di valore.
“L’arte moderna è un grande carnevale – dice Mario Vargas Llosa – in cui si mescola di tutto, il talento e la furbizia, i creativi e i pagliacci. E, questo è l’aspetto più grave, non c’è modo di fare distinzioni, di separare le scoria bruta dal puro metallo. E proprio perché ormai non esistono denominatori comuni estetici che consentano di distinguere il bello dal brutto, il successo di un artista non dipende dai suoi meriti, ma da fattori estranei all’arte quali le sue capacità istrioniche o gli scandali o gli spettacoli che è in grado di organizzare o dalle manovre mafiose dei galleristi, dei collezionisti, dei mercanti e dall’ingenuità del pubblico smarrito e sottomesso”.
In ogni caso, vale la pena opporre una qualche resistenza poiché è la non-arte a pretendere di essere considerata arte; al contrario nessuna reazione provocherebbe se per essa si trovasse un nuovo nome, una nuova classe che comprendesse tutte le cose olezzanti, mal costruite, non significanti a cui si attribuisce un valore economico, e dunque di senso, attraverso un mercato bloccato, di fatto un oligopolio controllato da un gruppo di pochi eletti. Se per la non-arte si utilizzasse il termine “sgunz” non ci sarebbero problemi né fraintendimenti, non dovremmo tenere insieme forzatamente nello stesso ordine le statue di Fidia e la merda di artista di Piero Manzoni, la cappella Sistina e la Turbo Cloaca di Wim Delvoye, Caravaggio e le foto di escrementi scattate da Andres Serrano, il Cristo morto di Mantegna e il dito medio alzato di Cattelan. Gli oggetti “sgunz” avrebbero un proprio statuto ontologico (ed estetico), nessuno ne farebbe una tragedia, anzi sarebbe una branca del sapere da frequentare con giusta attenzione. Gli artisti che proseguono sulla linea tracciata da circa tre millenni continuerebbero a definirsi “artisti”, gli altri “sgunzatori”.
A ben pensarci questa dicotomia esiste già, basterebbe renderla evidente, costruendo una fenomenologia dello “sgunz”, codificandone i margini di azione: del resto Filippo Tommaso Marinetti, nella sua immensa preveggenza, destinò ai Manifesti la funzione di elencare le caratteristiche precise relative a tutte le modalità espressive di un Movimento. Dal punto di vista ontologico, lo “sgunz” è un oggetto ma anche no, essendo sufficiente una rappresentazione o una performance. Dal punto di vista estetico questo (non) oggetto o rappresentazione deve ignorare il più possibile l’idea di bellezza, di ornamento, di funzione. Dal punto di vista gnoseologico, possibilmente non deve avere significati certi, venendo meno il rapporto tra forma e contenuto, semmai significati ulteriori, non univoci, e difformi rispetto alla forma utilizzata quand’anche si possa in via residuale parlare di forma. Lo “sgunz” in sostanza è (o non è) un oggetto, deve massimamente tendere all’orripilante, all’informe, all’insensato (meglio se tutto insieme), deve essere il più nuovo possibile (questo è imprescindibile), deve autodefinirsi come “arte”, e avere un pubblico che pur non capendone la portata ne sostiene entusiasta il valore.
Ovviamente lo “sgunz” annovera storici e critici, curators e giornalisti, collezionisti e pubblico plaudente, galleristi e direttori di museo, restauratori, un nugolo neppure troppo esteso di happy few che governano quello che viene definitivo art-system. Gli storici e critici hanno elaborato una teoria, i galleristi la fanno propria, i curatori scovano la materia prima, cioè lo “sgunz”, in seguito i galleristi e i direttori dei musei la espongono, gli uffici stampa maneggiano i giornalisti amici, il mercante si arricchisce scambiandola, i restauratori se è il caso (spesso lo è) la restaurano, il collezionista ne fa incetta godendo di un beneficio sociale poiché attraverso questa neolingua si eleva rispetto al borghese grasso e al povero incolto, il pubblico generico applaude senza capire il senso.
Lo “sgunz” è una fede che non prevede eterodossie, per cui i custodi del sacramento sono inflessibili: ammansiscono i fedeli in cerca di ricompensa sociale con ferrea determinazione. Il sacramento passa di bocca in bocca e tutti i fedeli ripetono la liturgia senza comprenderne il mistero. Quando provi a obiettare, le risposte sono sempre le stesse: se tenti di dire che lo “sgunz|” è brutto ti guardano perplessi, “come fai a dire bello, non esiste la bellezza oggettiva, al massimo può dire che ti piace una cosa”; se davanti a una “merda” insisti che però il brutto oggettivo esiste, restano ancora più perplessi, “allora sei è un nazista, sei uno di quelli che vuole distruggere le opere d’arte perché non ti piacciono”; se azzardi a dire che è incomprensibile replicano “che anche Caravaggio all’inizio non venne capito” ma che poi fu acclamato e dunque “è un problema tuo”; se dubiti sulla modestia del manufatto ti schifano “non mi dire che sei è uno di quelli che pensa che avresti potuto farlo tu… conta l’idea”; se non convinto infine persegui a sostenere che l’idea conta ma se la forma non è adatta non è arte, ti guardano con commiserazione e passano oltre; se infine ti ostini e magari propendi per l’arte della tradizione, per esempio un quadro ben dipinto, sbottano nel classico “ci faremo ridere dietro…”.
Quando su un ponte di Venezia mi imbatto nella Kaufmann della premiata ditta Kaufmann che insieme alla sorella conduce l’eponima galleria Kaufmann, cioè le cosiddette sorelle Tenaglia perché la nuova sede è in via di Porta Tenaglia a Milano, quando la incontro e intorno la laguna è splendida, un giorno di giugno di Biennale 2009, della 53esima Biennale di Daniel Birnbaum, il cui padiglione Italia è stato affidato dal Ministero della cultura – la Kaufmann pensa grazie anche al mio intervento di provvisorio consigliere del ministro – al duo “reazionario” Beatrice Buscaroli e Luca Beatrice, 1500 metri quadri dove i due Beatrice hanno esposto (dei) quadri, sculture, foto e video – 1500 metri quadri dove, imperdonabile peccato mortale, sono state selezionate anche opere pittoriche rispetto all’Arsenale ai Giardini e agli oltre settanta padiglioni di really sgunz, decine di migliaia di metri quadrati di vero sgunz – la Kaufmann-Tenaglia mi guarda come per uccidermi e mi dice testuale “cosa hai fatto? Ci ride dietro tutto il mondo…” ed io divento più piccolo e penso al mondo intero dell’arte che ride alle mie spalle perché verranno esposti quadri e non cose sparse a terra, specchi rotti, lampadari fatti di assorbenti, ippopotami di fango, wuberoni rosa, sacchi della spazzatura come è successo in passato. Lo stesso giorno mi inoltro nello sgunz lagunare con curiosità e all’Arsenale attraverso lo spazio Pae White-Kaufmann nel quale capeggia un mega lampadario ricoperto di semini e di miglio e ad ore prestabilite si radunano alcuni chioccolatori che imitano il verso degli uccellini. La californiana Pae White protégé della Kaufmann lavora sullo spazio (tutti gli sgunzatori lavorano sullo spazio), spesso in modalità site specific (tutti gli sgunzatori lavorano in modalità site specific, come dei parassiti vivono di quello che attaccano), in un campo tra arte, design, e arti applicate (tutti gli sgunzatori lavorano in un campo tra arte, design, arti applicate, ubbidendo al sublime, cieco verbo della “contaminazione”, da citare a piena bocca e possibilmente a occhi socchiusi) e, partendo dall’architettura, approda a una “narrativa spaziale”.
I critici parlano di questa stanza del miglio e dei fringuelli come di una splendida opera d’arte “surreale ed effimera” e nessuno finalmente ci ride dietro.
* da Ars Attack. Il bluff del contemporaneo (Johan & Levi, 2014)