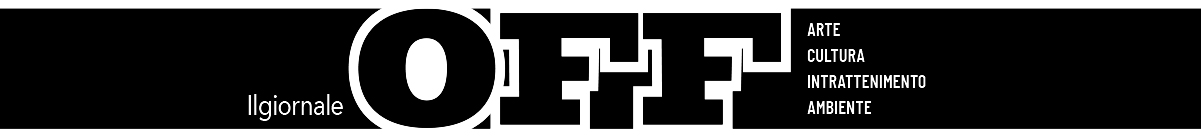Come studiare con efficacia un’opera d’arte? Come unire, nel medesimo approccio, rigore accademico, analitico, storico-filologico da un lato e ispirazione creativa, demiurgica, intuitiva dall’altro? Come farsi carico, insomma, dell’interezza – splendida e perturbante – del capolavoro artistico, che sempre in sé riunisce l’oggettività formale e iconografica della rappresentazione tematizzata e il mistero indicibile del senso che la abita, nella relazione simbolica con l’“altro” da sé (sia esso l’artista, il contesto, la storia)?
A queste domande cerca di rispondere lo storico dell’arte Alessandro Rossi nella sua ultima pubblicazione, Gestualità leonardesca. Tra teologia cristiana e virtus pagana: la Vergine delle rocce e la Lucrezia romana di Marco d’Oggiono (prefazione di Claudia Cieri Via, Mimesis, Milano-Udine 2020). Un titolo complesso per uno studio altrettanto colto ed erudito, che mira a unificare sapientemente un tema particolare – la disamina storico-artistica delle due citate opere di Marco d’Oggiono, artista rinascimentale allievo e collaboratore di Leonardo da Vinci – e un’istanza universale – un approccio metodologico volto a sondare l’opera d’arte nel suo sfaccettato pluriversum, considerando non solo la rappresentazione iconica in essa inscritta, lo studio dei materiali, la ricostruzione della sua committenza (di estremo prestigio nel caso delle due opere di d’Oggiono, secondo la strutturata indagine condotta dall’autore) genesi e storia, l’attenzione alle fonti, ma l’intero impianto etico, teologico, storico-religioso, simbolico-archetipico, antropologico e filosofico che essa intercetta e riflette.
L’attento studio delle due splendide tavole di Marco d’Oggiono, condotto con la perizia di cui solo uno storico dell’arte può disporre, s’infrange di fronte a un limite ermeneutico: è possibile indagare rigorosamente quell’eccedenza dell’opera che sempre si sottrae allo sguardo attento del ricercatore armato di rigore filologico e razionale? Rossi cerca il segreto dell’opera, il suo mysterium tremendum, proprio muovendosi nel visibile della forma estetica e del segno artistico. Sonda così il da pensare dell’arte – in quanto «uno dei principali obbiettivi della storia dell’arte è quello di provare a cogliere l’invisibile nel visibile, di far rivivere a partire da ciò che resta (immagini dipinte o scolpite) ciò che è stato e non è più (la cultura, la spiritualità e la sensibilità estetica degli uomini vissuti nel passato)» (p. 23).

Rossi lavora su un sottile crinale, che definisce, sulla scia di Aby Warburg, come orientamento antropologico della storia dell’arte: non abbandona mai l’ancoramento all’opera per avventate interpretazioni soggettive o fantasmagoriche, ma al contempo si scontra con la materialità dell’oggetto estetico per riconoscerne la dialettica di sovrabbondanza. Intrisa di storia e memoria, l’opera d’arte dice di qualcosa che oltrepassa il passato e interroga i posteri, attingendo a un portato di simboli, archetipi e strutture estetiche e gnoseologiche che rimandano all’alterità radicale, alla sovrastoria e al dominio del numinoso. Il sacro, nella sua dimensione metafisica, si relaziona costantemente alla narrazione storica: dall’incontro/scontro fra le due dimensioni sorge l’evento dell’arte. Esso testimonia la veridicità del reale, oltre ogni preconcetto e chiave interpretativa: gli artisti mostrano, come spiega Benjamin Fondane, «che la vita, la morte, la sofferenza, la miseria, l’amore, la collera, la noia, l’ignavia, il sacrificio, la solitudine, l’ignoto, il mistero, la fatalità, la libertà… esistono», poiché «loro hanno visto che il singolare è più importante del “generale”, il contingente più vero dell’immutabile e dell’eterno, l’inintelligibile più profondo e più ricco dell’intelligibile» (Falso trattato di estetica. Saggio sulla crisi del reale), in un ribaltamento paradossale delle gerarchie cui solitamente siamo abituati: la singolarità dell’opera è più profonda dell’universalità del concetto.
Rossi tenta di ricostruire la fisionomia dell’arte ricorrendo a una straordinaria varietà di riferimenti teorici: da Erwin Panofsky, col suo principio correttivo dell’interpretazione al paradigma indiziario attorno a cui si muove Carlo Ginzburg, dall’ermeneutica della complessità di Ioan Petru Culianu a Walter Benjamin, con la sua nozione di “costellazione”, entro cui l’«immagine è dialettica in posizione d’arresto» (p. 273), passando per la coincidientia oppositorum di Nicola Cusano.
L’opera di Marco d’Oggiono assurge così a exemplum fecondo: il suo radicamento nella continuità rinascimentale fra tradizione pagana e novitas cristiana è il terreno privilegiato per riscoprire nelle figure dei suoi dipinti i germi della prisca sophia. La centralità della gestualità nelle opere di d’Oggiono, in cui il linguaggio dei gesti è fondamentale nella strutturazione degli schemi compositivi e, dunque, delle sfumature archetipiche di significato trasmesse allo spettatore, arricchisce ulteriormente l’esigenza di una ermeneutica dell’arte avvertita.
In ultima istanza, «restituire alle opere d’arte la funzione e la bellezza di essere dispositivi efficaci che consentono al virtualmente a-storico, meta-storico o trans-storico e universale di accadere, manifestandosi nello storico, è il compito che la storia dell’arte antropologicamente orientata si propone di svolgere» (p. 269).