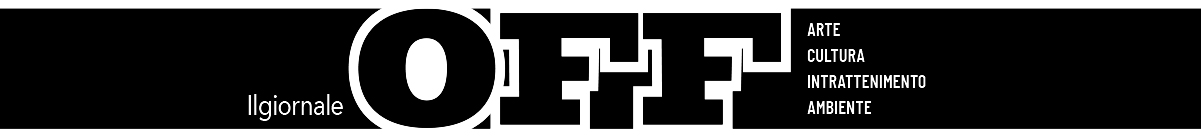Ormai parecchi anni fa, in una giovanile dipendenza da fascinazioni viscontiane, dedicai una mostra in un’importante galleria romana all’emergente figurazione italiana, chiamandola leopardianamente I corpi e le mura. Mi piaceva l’idea di stabilire un rapporto serrato, verificandone la tenuta, tra la figura umana e un qualche sfondo solido, certo, che facesse risaltare entrambi come un’indubitabile prova di realtà. La mostra attuale, che presentiamo nelle belle sale del Museo Bilotti – habitat ancora viscontiano, benché involontario stavolta – è un’estensione e un ingrandimento modulato sull’onda di frequenza 2.0 di quella mostra lì. Quindi ne è anche lo stravolgimento. Ciò che allora appariva intimo e classicamente novecentesco si è infatti dissolto, perduto, perché il nuovo secolo, e il nuovo millennio non suggeriscono intimità, né (ci) proteggono (da) nulla. E il dialogo tanto desiderato, in quel mite, semplice appoggiarsi della figura a un muro – benché proprio quella mitezza nascondesse a malapena una mia insofferenza e la voglia di regolare qualche conto esistenziale e culturale con un establishment che disapprovavo – pure è andato smarrito, deflagrando, pretendendo altro spazio, esponendoci al pericolo e a bilanci per forza di cose fondamentali, proiettandoci in una flyzone turbolenta, da esplorazione inquieta, quasi da combattimento. Là dove c’era una stanza misurabile con pochi passi ora c’è la percezione allarmata di un mondo, non so se mi spiego. E in fondo non può essere che così.
Linee di confine si presenta come una mostra-periscopio: affiora e lentamente si guarda intorno. Ciò che vede e ci fa vedere sono le città e i nostri corpi, i nostri volti. Ciò che vede e ci indica, ancora, con un gesto quasi sproporzionato nella sua apparente, così necessaria, inattualità, è la natura. E il confine tra tutto ciò, tra queste grandi placche alla deriva sulla corrente della nostra esistenza e della nostra mente, non è soltanto il bordo irregolare che nello scorrimento divide cosa da cosa, e nella separazione le illumina, ma anche la linea che unisce. È la stessa fertile ambiguità che rende araldica, sinteticamente e perfettamente aderente al tema, quasi ne fosse il brand, l’installazione di Angelo Bucarelli. Confluenze, convergenze, congiunzioni: i confini sono tessuti connettivi, fili dalla tenuta resistentissima, oltre che limiti evidenti. Una casa, una faccia, un albero? Stessa sostanza, lo sappiamo bene.
Aggiungiamo subito che abbiamo selezionato opere importanti, lavori imponenti, che ben rappresentassero i singoli artisti. I quali certo non li si potrà mai accusare di mancanza di carattere, perché qui ognuno di loro ne ha da vendere. Nessun minimalismo, tra l’altro, non le sue supponenze lavative né le sue smisurate ambizioni per arredamenti cool. Piuttosto, contromano rispetto a qualsiasi tendenza allo sradicarci e al diventare definitivamente incomprensibili a noi stessi, prevale un massimalismo figurativo che in assetto anche spettacolare superi il mood ormai universalmente diffuso di “sensazioni”, stimolazioni ottiche, incitamenti a delinquere, induzioni a stati di malessere, e invece susciti, con chiarezza di rappresentazione e di narrazione, l’impatto con temi non necessariamente circoscrivibili al nostro dannato ombelico, con scene maggiori e immagini e simboli che campeggiano e lampeggiano qui, e ora.

Poniamoci una domanda preliminare: quale terra dell’arte stiamo concretamente perimetrando e nominando? Quali sono i punti cardinali che tocchiamo? Vediamo. Gerusalemme e il suo Muro del Pianto, onda anomala di una fisicità solenne, impressionante riparo, consolazione (Massimo Giannoni), una Istanbul sorvolata come da un drone curioso, magneticamente attratto da sciami luminosi, costellazioni radenti il suolo, spettacoli notturni (Tommaso Ottieri), New York e Roma nel loro farsi e disfarsi, nella loro costante, animalesca biologia architettonica (Bernardo Siciliano, Giorgio Ortona), le limpide rotazioni aeree di una Milano vuota, desertica, puro gioco e divertimento di geometrie cromaticamente sature,

là dove figurazione e astrazione si dicono buongiorno (Marco Petrus), un epicentro antico romano altamente visionario, come un’ombra strappata via a morsi, a frammenti, per uno sbocco di troppa passione (Paolo Picozza), una Napoli oscuramente e poeticamente narrata al modo di una sequenza di apparizioni miracolose (Adelaide Di Nunzio), o le città delle attese, che siano Basilea, Parma, ancora Milano, in questa specie di topografia delle sparizioni, dove mai lasciare il nitore e l’ordine funzionalista degli edifici al vuoto, ma a tutto un teatro di emozioni individuali, ben tenute dentro, come in Hopper (Alice Pavesi). Metteteci il progetto fotografico dedicato da Sandro Maddalena all’Ucraina, alla sua crisi politica, umana, sociale, metteteci dunque proprio quella desolazione e quella superstite bellezza spontanea, non calcolata, dura a morire malgrado tutto, e avrete davanti a voi il perimetro di una finis Europae stranamente dolce, silenziosa, il suo inequivocabile promemoria spirituale lasciato allo sguardo, dove il centro è fragile e i bordi da pattugliare, da sorvegliare. Anche se nulla qui è detto direttamente, brutalmente, ma soltanto suggerito, maestosamente bisbigliato: questa, in fondo, non è la visuale periferica dell’occhio occidentale?

Intrecciando le robuste corde di cui è fatta la stoffa della mostra, la solitudine espressa dal Cristo di Siciliano, da questa attualizzazione e perpetuazione dei potenti Cristi italiani che da Masaccio in poi ci hanno commosso, una figura che qui, in zona arte e in modalità più laica, sembra chiedere asilo, dopo essere stata socialmente, incredibilmente, come un tempo gli dèi pagani, scacciata ovunque, è la medesima solitudine dei calchi dei volti degli immigrati morti in mare – altri esuli, altri esodi – emersi non da onde questa volta, ma dall’ossatura e dai ritmi astratti di una metropoli spettrale con il lavoro di Christian Leperino; ed è la stessa che assedia e anima l’eroismo vano, il trafiggente desiderio delle azioni che valgono, delle figure di Stefania Fabrizi, che nelle sue grandi carte da spolvero fa sentire un attivo, pulsante “tramando” (direbbe Francesco Arcangeli) sironiano; solitudine e non so che fierezza che infine si ripercuotono nel face to face cui ci costringe Roberta Coni, questa “fedele al volto” che nel dipingere e investigare e moltiplicare l’essenziale, atterrando su una faccia come una navicella sull’unico pianeta possibile, non ha paura.

Continuiamo ad annodare. Perché in fondo il Muro e il Cristo, la loro capacità di irradiazione fisica e spirituale, questo loro ristabilire, comunque la si pensi, il contatto col grande, valgono la meravigliosa, indomita Montagna di Picozza, la sua presenza massiccia come preludio, o custodia, di un’assenza, la sua calma distante. Per il pensiero, anzi per la devozione buddhista le montagne sono divinità, soggette, come tutto d’altronde, a cambiare e a dissolversi un giorno. E questo senso della metamorfosi naturale, di cicli che inevitabilmente si compiono li ritrovo negli alberi autunnali e tonali di Giovanni Frangi, un artista per il quale, come per Cézanne, la pittura è davvero la natura in paradiso, né si potrebbero mai concepire, nel loro reciproco specchiarsi, l’una senza l’altra, perché come l’arte, anche la natura, il suo fondo sacrale, chiede di essere guardata, ammirata, capita. Una connessione complessa, fittamente tessuta, tra natura e architettura, tra ciò che possono, intrecciandosi nell’aria, i rami degli alberi e il gesto creativo umano, fosse anche quello di un semplice costruttore di nidi, la stabilisce Manuel Felisi, in lavori dove perfino la memoria del corpo, delle sue vie di capillare scorrimento vitale, è resa visibile e custodita, perché è così che si ha cura di un dono prezioso.

Sulle linee di confine, è facile assistere a momenti intensamente rivelatori. E questi di certo nascono dalla contemplazione degli spazi e delle profonde notti che si spalancano e trascolorano sulle grandi tele di Thomas Gillespie e Pete Wheeler. Un alto arco da buio a buio. Si tratta di quadri che sottostanno al regime notturno delle immagini: una casa vibrante nel silenzio, come fosse un animale da preda, l’orizzonte, la remota espansione di un crepitio, di un bagliore, indicati con la mano alzata. Quello è un confine, più lontano ancora.
______
> Linee di Confine – la natura, il corpo, le città
a cura di Marco Di Capua
Museo Carlo Bilotti
viale Fiorello La Guardia 6, Roma
fino al 21 giugno 2015