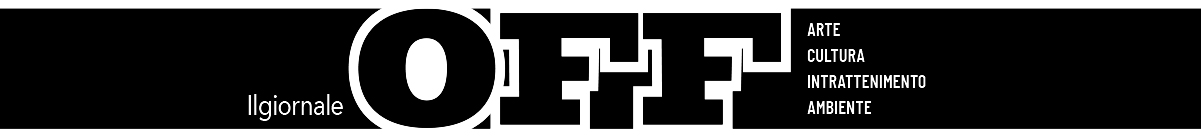In questi giorni, sottotraccia, sta proseguendo una polemica che ha per oggetto Cattelan e la sua ultima “opera”, la copertina del New York Times Magazine in edicola dal 22 febbraio. Il critico Alessandro Riva su IFmagazine, ripreso poi da altre testate on line, ha evidenziato come l’immagine di Cattelan, un mappamondo interamente pittato di blu a esclusione degli Stati Uniti, ne ricordi una del tutto simile dell’artista Francesco De Molfetta. Contemporaneamente, si è scoperto che anche l’artista americana Olivia Locher rivendica la maternità dell’idea, poiché nel 2013 aveva pubblicato – per paradosso sul New York Times Style Magazine (il cugino della testata principale del NYT) – una serie di fotografie tra cui appunto How to see North America, praticamente ugale a quella del Nostro Artista Nazionale.
Riva sintetizza in questi termini la questione: “Se l’opera di De Molfetta (al quale, da un punto di vista temporale, va data però di diritto la paternità dell’idea, dal momento che la sua opera risale al 2004), era leggermente diversa da quella di Cattelan sotto vari aspetti, seppur secondari (la vernice era bianca anziché azzurra, il pezzo di carta geografica rimasto “sverniciato” era il continente europeo anziché quello americano, e la stessa motivazione “concettuale” del lavoro era differente, sebbene l’dea fosse simile sul piano formale), la foto di Olivia Locher è talmente simile, anzi identica, da rendere difficile, se si ha un minimo di onestà intellettuale, non parlare di plagio, per lo meno dal punto di vista estetico“.

Orbene questo sarebbe il nocciolo della questione: il plagio. Cattelan che è molto sveglio potrebbe aver visto, certo, l’opera del meno famoso De Molfetta, e la foto della Locher. Ma questo non basterebbe a far sussistere il plagio, che è una sorta di reato la cui fattispecie risulta alquanto indeterminata e che raramente viene punito: ci sono casi nella letteratura contemporanea di scopiazzature testuali al limite del ridicolo che però non vengono esposte neppure al pubblico ludibrio.
Nell’arte antica e anche in quella contemporanea (con alcuni distingui) più facile definire il falso che il plagio, tanto che perfino di fronte a patenti appropriazioni di opere altrui il potenziale plagiato non riceve nessuna soddisfazione. L’esempio che analizza Marc Fumaroli nel suo Parigi-New York e ritorno (Adelphi 2011) è quello dell’artista Richard Prince che per una mostra al Guggenheim di New York ha esposto gigantografie di immagini di Jim Krantz, un fotografo commerciale, che erano servite per una campagna pubblicitaria della Marlboro. Ovviamente Prince si era peritato di acquistare i diritti dall’azienda e in fase di processo si è sostanzialmente difeso sostentendo che le immagini pubblicitarie non hanno “autori”.

Venendo eliminati i criteri del gusto, del bello, del sublime, del capolavoro, dell’originale, del talento, del genio, della maestria tecnica, della poesia, in qualsiasi forma si presentino – dice Fumaroli – non resta più niente nell’arte contemporanea. E cade anche la pretesa che sia sufficiente l’idea per determinarne il valore, poiché anche l’idea può averla avuto un altro che non sia l’artista.
A maggior ragione non ha nessun senso parlare di plagio: posto che nell’arte antica i temi erano sempre gli stessi e contava la capacità di realizzarli (pensiamo per esempio alle migliaia crocefissione o di maternità…), a fortiori nell’arte contemporanea il contenuto (cioè l’idea) che dovrebbe valere – come ci hanno fatto credere – non vale niente, neppure vale come è stata realizzata l’opera, vale soltanto l’aura che l’artista riesce a trasferire nel manufatto. Pensiamo alla Brillo Box che fu realizzata da un pittore espressionista rimasto sconosciuto, James Harvey, e che fu poi clonata da un predatore come Andy Warhol.
Di fatto, nell’arte contemporanea prevale la razzia, tutti i più acclamati artisti contemporanei sono al massimo razziatori di idee altrui; di fatto, nell’arte contemporanea prevale la griffe, il marchio, il marketing, l’artista che, come il melo fa le mele, fa le opere d’arte e non importa se siano belle o brutte, finite bene o male, la cosa fondamentale che abbiano il logo sotto, come le borsette di Louis Vuitton.