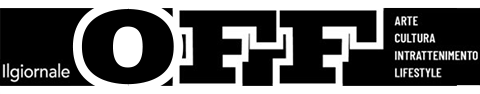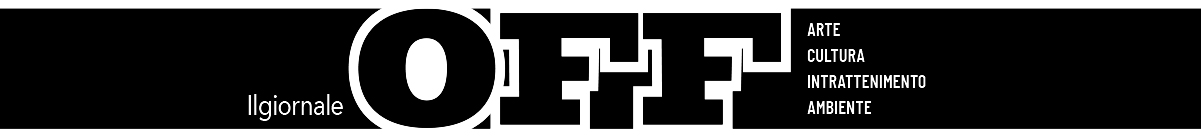Non avremmo dovuto rimuovere l’Iliade, spiega James Hillman. In Figure del mito (Adelphi, pp. 364, euro 32), lo psicanalista americano spiega i misteri dell’inconscio collettivo partendo dagli archetipi junghiani e dalla funzione del mito. Un capitolo tocca il nervo scoperto di questi giorni. Guerre, armi, arieti, Marte, in cui riprende un suo libro dal titolo icastico uscito nel 2005: Un terribile amore per la guerra. La contiguità di amore e guerra può scandalizzare. Ma siamo costretti ad ammettere che c’è chi la ama, anzi: la venera. La guerra fa orrore al nostro mondo così ben educato, ma non è stata esorcizzata e ci gioca brutti tiri. Cambia forma, attacca all’improvviso costringendoci a reagire. Non ha giovato all’Occidente l’atteggiamento americano, che tende a giustificarla con ipocrisia.
La guerra è un’emozione primordiale, un rito, ha una sacralità. Non compare nei Vangeli, ma c’è nella Bibbia, nel Corano e nell’epica indiana. Se per qualcuno è santa, per noi è mitica, nel senso letterale del termine. Per la filosofia platonica e quella indiana è necessaria, altrimenti non invocherebbero una classe guerriera a tutela del bene comune.
Nel guerriero si esaltano alcuni sentimenti del cuore: onore, nobiltà, coraggio, saldezza nei principi. Perciò non possiamo scacciare Marte dalla nostra storia, né negare il “carattere trascendente” della guerra. La sublimazione passa per l’accettazione, sembra dirci Hillman. Accettando la natura dell’umanità e della storia, si capisce che pace e guerra sono collegate e la prima spesso è solo la fragile conseguenza della seconda.