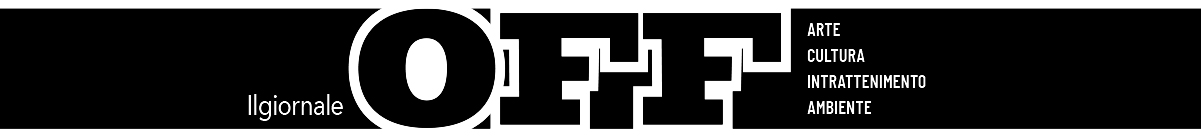Dopo aver lavorato per diversi tempo a teatro, Germano Maccioni ha deciso di immergersi nell’ambito cinematografico come regista. A distanzi di anni dal suo “Fedele alla linea” in cui racconta vita e musica di Giovanni Lindo Ferretti, è arrivato a grandi trionfi, ottenendo anche la nomination come miglior film al Festival di Locarno nel 2017, con il film “Gli Asteroidi”. Adesso è giunto il momento di raccontare il percorso di uno dei documentaristi (e non solo) più affascinanti del nostro cinema.
Germano, il tuo percorso artistico nasce sulle tavole del palcoscenico nelle vesti di attore. Cos’hai provato al tuo primo spettacolo poco prima di entrare in scena?
Dunque, io considero il teatro la base, le fondamenta solide, di quello che è stato il mio percorso. La prima volta che sono andato in scena paradossalmente fu con il testo più difficile della storia, Amleto. Io cominciai con un gruppo che si chiamava “Teatro dell’argine” che penso esista ancora adesso, ma per puro caso, in quanto non avevo nessun tipo di interesse per il teatro o la drammaturgia, ma in quegli anni nel mio paesino, in provincia di Bologna, era un metodo di prevenzione alla tossicodipendenza, dato che negli anni novanta molti giovani usavano droghe. Quindi a qualcuno venne l’idea di portare un laboratorio di teatro, una sorta di centro giovanile e dunque chi si faceva le canne di sicuro non sarebbe mai venuto e invece molta gente ha avuto la fortuna di trovare un’altra strada. Partimmo proprio da Amleto e pensa che la scenografia andò in fiamme, una cosa meravigliosa. Poi, poco dopo ebbi la fortuna di fare un provino con Giancarlo Cobelli, uno dei grandi maestri del teatro italiano, e poco più che ventenne inizia a lavorare con lui e così mi trovai in turnè nel Macbeth con Kim Rossi Stuart e Sonia Bergamasco.
Come hai affrontato il “dramma scozzese”?
Sicuramente è un testo molto oscuro ma per me che avevo ventun anni fu una palestra a tempo pieno in quanto facevo diversi ruoli e poi, stare venti giorni in scena al Piccolo, un mese al Quirino e poi tutte le piazze. Quindi fu una vera e propria palestra, un’esperienza fantastica. Poi Cobelli è stato un maestro per me, facendomi capire il valore di questo mestiere. Una volta eravamo in una saletta a Roma per delle prove e a me venne spontaneo accennare un fischio e lui mi disse: “ Germano, tu quando entri in chiesa fischi?” e quella fu una lezione meravigliosa in cui capii l’attitudine di quest’uomo verso il teatro e poi da lì in avanti ebbi la fortuna di lavorare con altri grandi, lavorando sul palcoscenico fino al 2006-2007 per poi passare dietro la macchina da presa. Però diciamo che il teatro mi ha dato un modo molto solido nell’imparare e non a caso, quando ho fatto il mio primo cortometraggio di finzione, ho avuto l’ardire di chiamare Roberto Herlitzka che è un mostro sacro della recitazione e in qualche modo, lo dico con molta umiltà, sapevo come prenderlo.
Dopo aver frequentato l’American Conservatory Theatre di San Francisco torni in patria ed entri a far parte del laboratorio “Bottega” di Giovanni Lindo Ferretti. Com’è stato lavorare al suo fianco come discepolo?
Allora, discepolo no. Lui stesso direbbe no alla parola discepolo, ma effettivamente quel laboratorio fu una grande cosa, perché Giovanni intendeva questo luogo non come una vera scuola ma più come una bottega in senso medievale, come quando i pittori istruivano i propri apprendisti. In questo posto ci si occupava di musica, teatro e cinema e fu una grande esperienza da cui nacque un’amicizia con Giovanni, tant’è vero che lui aveva il progetto di un film che voleva che io interpretassi, un Western con le atmosfere di “Dead man” di Jim Jarmusch. Dato che stette male il film non si fece mai e pochi anni dopo io passai dietro la macchina da presa e forse proprio per questo, in maniera piuttosto inconscia, è nato “Fedele alla linea”. Devo dire che il periodo della “Bottega” fu molto interessante perché si toccavano filosofia, musica, spiritualità, letteratura. Quindi fu molto importante per me.
Poi hai debuttato al Cinema come regista dirigendo molti documentari, peraltro pluripremiati. Un grande esempio è “Lo Stato di eccezione” che vanta la presentazione al sessantacinquesimo Festival di Venezia(giornate degli autori), Nights Film Festival, Doc in tour, Mantova Film Festival e molti altri. Cosa cerchi di raccontare con la visione documentaristica?
Credo che il documentario sia la possibilità più immediata che abbiamo per esprimerci verso il cinema. Pasolini diceva che noi, essendo condannati ad un’eterna soggettiva, utilizziamo la settima arte come una metafora di questa condizione e il documentario ti da senza una drammaturgia la possibilità di relazionarti al reale. “Lo Stato di eccezione” fu per me un’impresa folle perché andavo a maneggiare del materiale incandescente in quanto si trattava di un processo di una strage nazista, forse la più atroce e la più vasta dell’Europa occidentale, ossia quella di Marzabotto, a sessantadue anni dai fatti. In Italia, dopo la guerra doveva celebrarsi una sorta di Norimberga perché vi furono più di trecento stragi nazi-fasciste i cui documenti vennero però fatti convogliare a Roma e poi, per dinamiche di amnistia e quieto vivere internazionale per via della Nato, questo processo venne messo a tacere prima di nascere. Solo negli anni novanta vennero ritrovati questi documenti. Dunque io mi trovai a mostrare questa storia pazzesca, questo racconto incandescente che aveva bisogno d’essere raccontato.
Nel 2008 dirigi il fortunato “My Main Man. Appunti per un film Jazz a Bologna”, un docu-film sul Jazz Festival. Quanto c’è di tuo, dato che sei bolognese, nel film?
Guarda, spesso faccio un documentario per colmare delle lacune come nel caso del processo di Marzabotto, accorgendomene soltanto dopo. Ad esempio io ignoravo che Bologna fosse una delle capitali del Jazz europeo per cui di me c’è tutto, c’è l’aderire a questa città che dagli anni cinquanta ha accolto, per certi versi anche fagocitato, musicisti un po’ allo sbando. Penso a Chet Baker che ha vissuto qui e che dormiva spesso nella cantina di un dentista al quale rubò delle ricette su cui scriveva la prescrizione di un oppiaceo che trovava in farmacia per farsi, solo che sbagliava a scrivere perché la data era all’americana e così lo beccarono e finì in galera a Lucca. Come lui tutti sono passati per questa città, una Bologna di cui sono figlio. All’epoca c’era una comunità che era predisposta all’ascolto, oggi sembra tutto così nostalgico.
Nel 2017 il tuo film di finzione “Gli asteroidi” ottiene largo successo al Festival di Locarno, ricevendo la nomination come miglior film. Quali sono state le difficoltà maggiori che hai riscontrato sul set, provenendo da tutto un altro modo di fare Cinema? Come hai scelto gli attori?
Guarda, venire dal documentario o dalla finizione, però corta, rispetto al budget che trovi su un lungometraggio ti può spiazzare. Diciamo che è come la prima volta che ci si trova a fare l’amore e ci si arriva col proprio bagaglio di storie, di esperienze. Sicuramente la gestione non è stata semplice anche perché avevo deciso di accostare degli attori professionisti come Pippo Delbono e Chiara Caselli a debuttanti assoluti e questa commistione per me è importante, come c’insegna tutta la cinematografia dal neorealismo in poi. Tutti gli attori giovani gli abbiamo scelti nelle scuole superiori ed erano debuttanti che dopo aver fatto un trainig attoriale con me, si sono trovati benissimo a stare in scena con dei grandi professionisti.
Facciamo un passo indietro, quando nel 2013 esce il docu-film “Fedele alla linea” in cui racconti vita e musica di uno dei personaggi musicali più controversi del nostro paese, il mitico Giovanni Lindo Ferretti. Ho notato che tutte le volte che lo inquadri è come se volessi restituire al pubblico una forte dimensione spirituale o quasi mitologica.
Guarda io direi mistica, però non in senso fumoso ma con l’idea del mistero. Giovanni sicuramente è impregnato di un’aria misteriosa, vive nel mistero. Nella sua vita c’è una nascita appenninica con tutti i credi del cattolicesimo, per poi diventare un giovane ribelle. Arriva il ’68, poi il ’77 con “Lotta continua” da cui poi uscirà, poi c’è il P.C., il punk, la Mongolia e tutto il suo Oriente ed infine c’è questo grande ritorno al cristianesimo. Questa visione religiosa, cattolico-romana ma in fondo misto-cristiana, è la stessa che io rivedo ne “Il vangelo secondo Matteo”. In molti però gridarono allo scandalo, dimenticando che Ferretti anche al tempo dei C.C.C.P. prendeva per il culo i soviet e in fondo anche il Partico Comunista, nonostante vivesse in quel contesto. A me interessava fare un film su un poeta e credo che Giovanni sia uno degli ultimi poeti. All’inizio il film doveva raccontare la sua impresa del Teatro barbarico con i cavalli ma quando sono salito sui monti, mi sono accorto che bisognava lavorare su di lui come protagonista e quindi il film si è ribellato a sé stesso ed è nato “Fedele alla linea”.
È struggente il racconto del suo “viaggio dell’eroe” ed il ritorno a casa da sua madre. Cosa ti ha colpito di più di questa storia?
Mi ha colpito tanto pensare al brano che lui scrisse ai tempi dei C.C.C.P. “Madre” che è come una preghiera dedicata alla mamma e che richiama “Supplica a mia madre” di Pasolini. È affascinante vedere appunto il viaggio di un punk-eroe, un cercatore, fino al ritorno a casa. Io credo che se Giovanni avesse continuato a frequentare il mondo dei C.S.I. con i concertoni rock o il mondo buddista nessuno avrebbe gridato allo scandalo, invece io trovo giusto questo suo ritorno. “Non fare di me un idolo, lo brucerò.” La storia di lui e di sua madre l’ho trovata potentissima, soprattutto nella sua fragilità. Attraverso il suo cammino ho potuto raccontare uno spaccato del nostro paese, dalla fine di un lungo medioevo che coincide con la strada asfaltata e l’arrivo della televisione, fino ai giorni nostri.
La scena finale non doveva essere quella vediamo. Giusto?
Si. Dovevamo riprende la nascita di questo cavallo, solo che è nato prima. Quando l’abbiamo saputo era mezzanotte e siamo partiti dal centro di Bologna verso Cerreto Alpi con le poche attrezzature e quando siamo arrivati lì fu meraviglioso perché eravamo in una zona remota, Giovanni dormiva e noi ci siamo avventurati. Era l’aurora e ci venne incontro il grande cavallo maschio in segno di protezione verso il cucciolo e sua madre, lo ricorderò per sempre. Siamo rimasti per mezz’ora muti e immobili per convincere l’animale che eravamo in pace e così, una volta avvicinati, ci siamo trovati davanti al cucciolo che per la prima volta cercava di alzarsi e il suo tremore l’ho trovato importantissimo perché restituisce la sensazione che ho provato filmandolo. Noi siamo gettati nell’esistenza e la vita non è un pranzo di gala, citando Sergio Leone che a sua volta citava Mao, e c’è uno sconcerto. Se guardi gli occhi di un infante non sono quelli della famiglia del mulino bianco. Sono occhi che ti sconcertano, così come un’animale che è appena venuto la mondo. Qui sta la base di tutto, fare i conti con il proprio mistero.