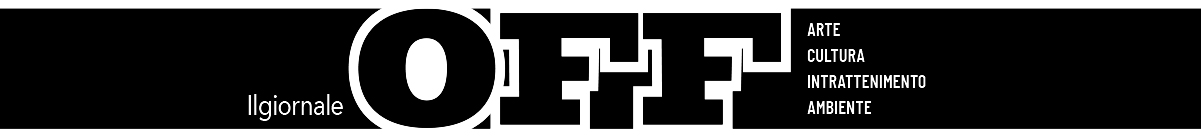Decisionismo e teologia politica. Come si declina il nesso fra queste controverse e affascinanti nozioni? A tentare un’audace risposta interviene un saggio recentemente edito per i tipi di Mimesis: Prima che il mondo fosse. Alle radici del decisionismo novecentesco (prefazione di Andrea Sandri, Mimesis, Milano-Udine, 2018, 112 pagine, € 8,50) di Orazio Maria Gnerre, ripercorre con sguardo filosofico le colonne portanti dell’evoluzione novecentesca della teoria decisionista – di destra come di sinistra – e del suo diversificato inveramento nei totalitarismi del Secolo Breve.
Al di là della raffinata trattazione di matrice filosofico-politica, lo studio offre alcuni spunti di estrema attualità. Il principale – o, almeno, quello che qui intendiamo abbozzare – riguarda la rivendicazione della centralità della sfera del Politico e, sulla scorta di Carl Schmitt, l’inalienabile connessione fra la dimensione teologica, il dominio del linguaggio – nella sua essenza mitico-simbolica – e la sfera politica.
Insomma, fuoriuscendo dalla teoresi: della politica, concepita come la sfera della decisione, ossia della determinazione sovrana, non si può fare a meno. Senza atti di decisione autentica, e quindi di separazione, divisione, determinazione, la comunità decade. Parlare di confini, sovranità, radici identitarie, non è una bestemmia. Non lo è perché è richiesto dal linguaggio stesso, che proprio fondandosi su strutture di distinzione esprime la condizione umana. La politica, come la teologia, risiede nelle profondità abissali del linguaggio. E lì tuttora dimora, in attesa di nuove possibilità di manifestarsi.
Di contro, nel regno utopistico dell’irenismo globalizzato e del politicamente corretto vige il dominio dell’informe e della stasi, l’immobilità dell’inorganico, la defezione di ogni polarità e prospettiva dinamica, la dittatura della liquidità. Può sembrare un paradosso, eppure la spoliticizzazione dell’immaginario che i soloni postmoderni amano definire “fine delle grandi narrazioni” annienta non soltanto i “grandi” paradigmi, ma anche i “piccoli”: ogni narrazione decade. Ogni visione del mondo si rarefà. Vale soltanto l’immediata attualità di un’immanenza deprivata di senso. Al suo interno, persino l’esperienza del singolo non è mai sovrana, in nessun caso si realizza quell’apice che Bataille definisce come «l’adesione lampante, e in un certo senso solare, all’istante». È, su scala collettiva, lo spettro che continua ad aleggiare nelle coscienze occidentali, quello della “fine della storia”. Un fantasma che puzza di morte più di ogni conflitto. Il suo fetore è quello di un cosmo in cui gli dèi e i simboli muoiono e si decompongono. Eppure, rimane l’auspicio che possano fungere da fecondo fertilizzante per nuove nascite e manifestazioni inattese.
La trattazione di Gnerre approfondisce i nessi e le variazioni della temperie novecentesca, segnalando – senza addurre alcun giudizio morale o di valore – come il farsi immanente dei princìpi teologici abbia informato tutte le categorie politiche, persino quelle moderne e modernissime, sino all’avvento del liberalismo e, di conseguenza, del paradigma dominante nella contemporaneità politica, culturale ed esistenziale dell’Occidente. Sulla disamina del significato di questo scarto poggia l’interesse principale del saggio.
Sullo sfondo, oltre al problema della ricostruzione ex nihilo di una legittimità politica realmente fondativa, rimangono le suggestioni che, perlomeno alla nostra lettura, sono sgorgate con limpidità e che abbiamo rizomaticamente tracciato. Nell’attesa del momento in cui «il Dio esiliato ritorna in un lampo inatteso e si situa di nuovo sul trono della storia, facendo sorgere un nuovo ordine dalle acque e dimostrando come la fine risulti essere l’inizio, e che in questa unità vi sia anche la possibilità di rapportare analogicamente l’uomo e Dio».