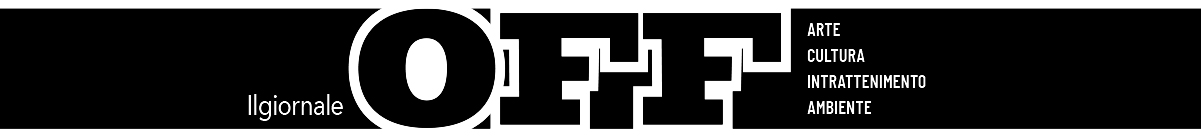Articolo tratto da Tempi, il settimanale diretto da Alessandro Giuli che aderisce alla rete di #CulturaIdentità
Articolo tratto da Tempi, il settimanale diretto da Alessandro Giuli che aderisce alla rete di #CulturaIdentità
Tranquilli, bimbetti, nessuna censura, niente inique sanzioni: qui si tratta soltanto di rimettere un po’ in ordine il vostro parco giochi (di Alessandro Giuli)
Premessa: non vado al cinematografo dal 1937, anno d’uscita di Scipione l’Africano, l’unico kolossal degno di nota nel secolo scorso; regista Carmine Gallone, sceneggiatore Camillo Mariani Dell’Anguillara (fior di esoterismo). E insomma me ne impipo allegramente della claustrofobica cinematografia contemporanea, brodino di coltura per rentier generati dal centro storico capitolino, dal quadrilatero milanese, dalle aree pedonali infiocchettate di culturame egoriferito e appena buono per la strapaesana festa del cinema romano, quella che vuo’ fa’ l’amerikana in mancanza di una sintassi da scuola dell’obbligo. Perciò chissenefrega dei cinematografari assistiti dalla mano pubblica, figli borghesi dei primi e degli ultimi baci… dei muccini o d’altri funghetti ombelicali; ovvero dei nipotini degeneri di Mamma Roma, più chic e mondani, che pretendono di ritrarre le periferie vere e quelle dell’anima, ma senza sapere com’è fatto un povero o che cosa sia l’interiorità (al netto della psicanalisi di Recalcati, e avrei detto tutto).
Stabilito ciò, peggio del peggio c’è l’aggressione sputacchiante mossa da varie latitudini giornalistiche contro la riforma cinetelevisiva promossa dal ministro della Cultura Dario Franceschini. Materia ancora in via di modellamento, ma che nella sostanza vorrebbe premiare per legge la manifattura intellettuale italiana, dotando d’un degno palco di rappresentanza in prima serata le produzioni cinematografiche nazionali ed europee. Opzione sindacabile, naturalmente, ma in linea di principio sana. Sopra tutto lì dove l’incentivo muova l’ingegno italico a miglior fattura e a più sicura competizione in un mercato che – ma guarda il caso – risulta largamente drogato, invaso com’è da produzioni statunitensi. E si dà il fatto che l’America abbia rispetto al cinema allogeno la stessa tolleranza mostrata dalle satrapie salafite nei confronti delle chiese cristiane. Odo già i primi singulti: “Vorresti forse toglierci House of Cards con tutto ciò che questa serie tivù sa dare, a noi intellettuali formatici sull’internet, in termini d’ispirazione?”. Odo già i secondi singulti: “Non siamo tanto indignati perché qualcuno ci leverà House of Cards: siamo indignati perché qualcuno ci ha già messo Don Matteo su Netflix”. Tranquilli, bimbetti, Netflix è un’industria che vuole fare profitti e non la vostra Fondazione Prada (nella quale peraltro c’è appena stata una mostra coi filmati della Carrà, mica di Lady Gaga). Tranquilli, bimbetti, nessuna censura, niente inique sanzioni: qui si tratta soltanto di rimettere un po’ in ordine il vostro parco giochi.
Da questo parco giochi si levano acute le vocalizzazioni americanomorfe, americanomorfiniche, e da ultimo anti franceschiniane, espettorate dal così detto “rattuso liberista”, inconsolabile maschera tragicomica che finge guerra alla dittatura del dirigismo pubblico. Il rattuso comune è colui che inclina alla lubricità. Il rattuso liberista ne rappresenta la variante non meno infelice e chiatta e butterata, ma più sofisticata: odiatore della natura che gli fu matrigna, trova compensazione nel fanatismo; inabile a far la mano morta con le ragazze, non certo per rango e stile (la sua condizione glielo intimerebbe) ma per congenita viltà, si rifugia nella mano invisibile di Adam Smith e scambia istericamente il libero mercato per il dio personale che gli varrà il sospirato riscatto etologico. Nulla a che vedere con il blasone mite del più rispettabile liberalismo, men che mai con la liberalità. Anzi, a voler dirla tutta, nella maggior parte dei casi il nostro infelice non ebbe mai il coraggio di confessare alla sua mamma che i soldini per fare in giro il “rattuso liberista” glieli passa il contributo pubblico all’editoria. E viva l’Itaglia.