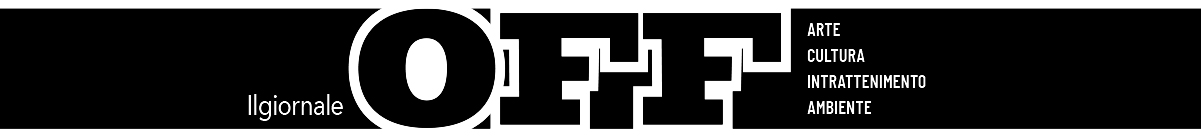uno
La vista dei corpi straziati gli dava il voltastomaco, ma il maresciallo Stella non poteva guardare da un’altra parte. Doveva per forza accettare l’incombenza, senza sottrarsi al proprio dovere. Una madre e un bimbo di soli sette anni erano riversi a terra in una posizione innaturale e costretti a una distanza altrettanto innaturale. Le vittime parevano passate attraverso un tritacarne. Schizzi di resti organici erano disseminati sulle pareti di cucina, sala, lungo i pavimenti. Dense strisciate nere continuavano su per le scale interne che conducevano a un qualche rifugio mai raggiunto. Una fuga senza speranza.
«L’assassino si è servito di un coltello da cucina». Disse un brigadiere alle sue spalle «Si è spezzata anche la lama».
Stella si voltò, guardò dove gli veniva indicato e gli tornarono in mente i premi del supermercato, quelli che prendeva sua moglie con i punti fedeltà, coltelli in acciaio, manico compreso, con la lama protetta da una guaina di cartone. Un’arma improvvisata, concluse tra sé. Come inaspettata poteva essere stata la furia omicida che aveva centuplicato le energie del boia.
«Usciamo». Disse.
Fuori, cercarono entrambi una boccata d’aria rigeneratrice. Ma non poté nulla contro il brusio dei curiosi attratti dal confuso viavai e dai lampeggianti. Oltre il cancello, nel breve tratto di via XX Settembre, il traffico era stato bloccato da alcune vetture di servizio che costringevano gli automobilisti a un giro appena più lungo per raggiungere il centro città. La penombra del tardo pomeriggio incombeva grigia su una giungla di rose disseminate sulla rotonda e a ridosso dei marciapiedi. Ormai sfiorite, sembravano aver assorbito l’odore della morte che aleggiava attorno alla villetta a tal punto da ripiegarsi su se stesse mettendo in bella mostra solo spine aguzze come artigli crudeli.
«Chi ha scoperto questo macello?»
«Il marito, il signor Guglielmo Campisi». E indicò un uomo appoggiato al muro, con la pelle del viso raggrinzita come un limone acerbo.
«Ha già dichiarato di essere stato impegnato in una riunione fin dalle dieci del mattino. Sostiene di avere molti testimoni».
A Stella parve di cogliere negli occhi dell’uomo il profilo del diavolo ballerino soddisfatto per aver costretto la vittima di turno a piegare la propria razionalità ai desideri degli incubi terreni. Chissà a cosa stava pensando, chissà cosa si poteva provare a lasciare a colazione moglie e figlio tutti interi e ritrovarseli, all’ora di cena, trasformati in protagonisti di uno spettacolo Grand Guignol, un mucchio di frattaglie sanguinolente e maleodoranti. Decise che non era ancora il momento di interrogarlo. Non ne avrebbe cavato niente di buono.
«Altri parenti?» chiese ancora.
«Una figlia, Serena. Aspettiamo il suo ritorno da un momento all’altro».
Stella si portò ai margini del giardino. Lo vide con il muso che aderiva a terra, legato alla catena. Avrebbe poi saputo che lo avevano chiamato Timur, come Tamerlano, Temur-i-Lang, lo Zoppo, per via della sua aria guerriera ma altresì per la zampa posteriore destra rimasta lesa dopo un incidente da cucciolo, motivo per il quale il suo vecchio proprietario aveva deciso di abbandonarlo. La famiglia Campisi lo avevano trovato una domenica pomeriggio, accanto al ciglio della strada di campagna, bisognoso di acqua, cure e affetto. Adesso era un bel pastore tedesco di cinque anni, un buon amico, un membro della famiglia.
Timur se ne stava seminascosto nell’ombra e al riparo di un breve tratto di siepe. Gli occhi erano opachi ma vigili e a tratti si concedeva lunghi sospiri e guaiti appena percettibili.
Stella gli si avvicinò. Timur drizzò le orecchie.
«Non possiamo nemmeno dare la colpa a te». Mormorò. «I lupi non usano coltelli.». Per un istante i loro sguardi si fermarono. Stella lo accarezzò e Timur sembrò essergliene grato.
due
Ventiquattr’ore dopo, Serena era salita sull’Alfa nera a fianco del maresciallo Stella. Lui cercava di proteggerla con la sua mole dalla vista dei curiosi assiepati fuori dalla caserma dei carabinieri. Piazza Vittorio Veneto si era trasformata in un muro di giornalisti, fotografi e curiosi.
…sono stati gli albanesi o i rumeni? Gridavano alcuni dei presenti, riportando un dubbio espresso da Serena Campisi in un primo interrogatorio e circolato con insistenza per l’intera giornata tanto che il sindaco si era spinto a dichiarare che la giustizia doveva fare in fretta il proprio corso per evitare che mostri arrivati da fuori potessero diventare una seria minaccia per la comunità alessandrina. E aveva pure convocato una manifestazione di protesta per quella stessa sera di fronte alla prefettura. E sopra a tutte, si levò una voce maschile più nitida a contenere la confusione creata da tanti stati d’animo aizzati da mezze verità:
«…dei in crep an Tani a cui bastard! »
L’autista cercò di sgusciare in strada muovendosi a passa d’uomo mentre alcuni colleghi in piedi cercavano di tenere a distanza la ressa. Poi la sirena prese a lacerare l’aria. Vibrava nelle orecchie di Serena Campisi e la costringeva a chiudere gli occhi dietro la maschera delle lenti nere, mentre la vettura imboccava la direzione dell’ufficio del Procuratore della Repubblica. E fu proprio dietro quel muro di vetro che lei rivide gli ultimi fotogrammi della sua esistenza di figlia e sorella. Proprio quelli che aveva finito di raccontare al maresciallo prima di salire in macchina con lui.
A lavoro terminato, si era tolta il cappuccio per liberare i capelli dalla prigione di sudore. Lentamente si era poi sfilata i copriscarpe, e la tuta antistrappo di plastica leggera, comperate al Self quindici giorni prima, mescolandosi tra i patiti del fai da te. Gli abiti non si erano sporcati. Anche se si era premurata di prendere jeans e maglione puliti per cambiarsi in palestra. Per precauzione, quelli indossati li avrebbe fatti scomparire nel cassonetto dell’Umanitaria Padana e nessuno li avrebbe mai reclamati. Dopo aver appallottolato la tuta, l’aveva ficcata in un sacco azzurro della spazzatura. E a sua volta nel borsone da volley. Lo avrebbe infilato di lì a qualche ora, finito l’allenamento, in un raccoglitore della plastica al quartiere Cristo, dove chiunque butta qualunque cosa e nessuno ci fa caso.
Il piano era perfetto, con qualche trucco rubato a CSI. Si rivide anche mentre affrontava il ritorno a casa pronta a interpretare il dramma in cui sarebbe stata trascinata. Doveva tenersi pronta a dare la descrizione del Mercedes bianco posteggiato dall’altra parte del viale, di fronte a casa sua, un vecchio modello, anche se non sapeva quale, con tre uomini sopra. Il finestrino era tirato giù e uno fumava. E il fumo della sigaretta gli offuscava i lineamenti. Aveva capelli corti, di questo era sicura. E la faccia che ricordava uno dei muratori che avevano lavorato nella casa a fianco qualche mese prima. Ma non era lui. Solo che più o meno si assomigliano tutti. Albanesi, rumeni, tutti slavi. Lei non poteva saperlo. E poi non doveva essere troppo precisa: che motivo aveva di ricordarsi tanti particolari proprio quella sera?
tre
Torino, carcere minorile Ferrante Aporti.
Dal diario di Serena Campisi.
…chissà se un giorno sarò capace di spiegarmelo.
Quando ho superato il cancello mio padre era già sul posto e nonostante ciò che aveva visto è stato capace di trovare la forza per allargare le braccia e accogliermi sul suo petto. Aveva le mani di ghiaccio, e mormorava di non entrare in casa e diceva pure qualche altra cosa, tanto per giustificare il caos e non mettermi in allarme. Timur invece era seduto accanto alla cuccia, messo alla catena. Quando si è accorto della mia presenza ha sollevato il muso e ha lanciato un profondo e inquietante ululato. Ho notato il maresciallo voltarsi verso di lui. Si sono fissati per un istante, quasi con sorpresa. Un gesto rapido. Un’intesa. Da complici.
In caserma, mentre guardavo le foto segnaletiche di albanesi e rumeni seduta davanti al computer nel suo ufficio, Stella ha incominciato a chiedermi di Timur. “Quanti anni ha, è buono, sa fare la guardia, avevo anch’io un cane così…” Parlava e mi fissava, e io lo sapevo che cercava di studiare le mie reazioni, ma non capivo dove volesse arrivare. Si era fissato nel voler sapere se Timur ululava spesso, perché quel pomeriggio, nelle ore della strage, i vicini dicevano di averlo sentito lanciare un latrato lungo e doloroso, ed era successo proprio mentre mi infilavo il casco prima di mettere in moto lo scooter per andare in palestra. “E questo non mi convince, mi diceva Stella, perché Timur avrebbe dovuto ringhiare come fanno di solito i cani con gli sconosciuti.” E una parola si appiccicava all’altra, e le domande incalzavano, con un ritmo sempre più veloce, ossessivo, fin quando, davanti al maresciallo, sono crollata.
Qualche ora dopo mi hanno consegnata nelle mani di un giudice.
Mi ha chiesto se quel pomeriggio avevo ucciso mia madre e mio fratello. Ho risposto di si, e lui mi ha chiesto perché. Proprio come aveva fatto il maresciallo. Ma con lui non ero riuscita ad aprire bocca. Al giudice invece ho risposto …perché non potevo più vivere con loro. Ecco tutto.