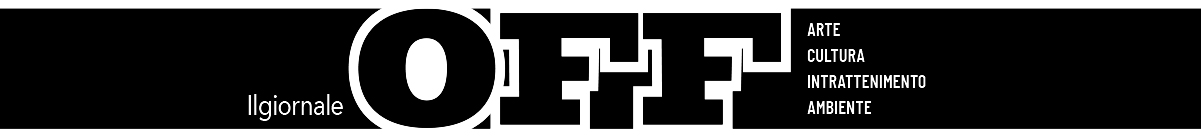Antonio Bido è quello che i cinephile e gli adepti dei più rinomati cineclub d’essai definiscono “regista di culto”. Un artista dalla forte potenza visiva quanto narrativa che nel corso della propria carriera ha diretto diverse pellicole, alcune delle quali sono divenute perle da collezione, alternando diversi generi e innalzando il thriller a cinema d’autore tanto che molti critici negli anni ’70, dinanzi ad opere come Solamente nero lo definirono addirittura superiore al principale artefice degli incubi di quegli anni, Dario Argento.
Come è diventato un regista di culto e da dove arriva il fascino del thriller che l’ha sedotta?
In realtà nasce come modalità per esorcizzare la paura della morte, sublimandola. Tra i miei massimi punti di riferimento cinematografico hanno sempre prevalso Bergman e Dreyer e questi narravano attraverso la macchina da presa quelle stesse tematiche che sentivo anch’io di dover imprimere su pellicola e le ho espresse nei miei primi due film sperimentali Dimensioni e Alieno da. Poi, quando si è trattato di fare il grande passo verso il cosiddetto cinema professionale avevo scritto una storia fortemente autoriale ma come opera prima è raro che ti venga data l’opportunità di realizzare film così complesso. Allora ho capito che lo stesso modo che avevo per poter raccontare determinate situazioni, determinati drammi, era attraverso il linguaggio del thriller. Infatti in entrambi i miei film di genere che mi hanno donato la nomina di regista di culto, Il gatto dagli occhi di Giada e Solamente nero, sono presenti quelle stesse tematiche che mi portavo dietro sin dall’inizio, soprattutto di carattere religioso e del contatto con la morte. In Solamente nero, ad esempio, racconto il dramma di un religioso e poi il film contiene addirittura una scena onirica in cui il killer dà la comunione alle sue vittime, qualcosa di estremamente blasfemo che alcuni hanno addirittura paragonato a Bunuel. Insomma, trovo nel cinema un’umanizzazione dell’assassino non per giustificarlo ma per rendere l’opera articolata. Infatti chi ha cultura cinematografica e la capacità di analizzare le cose in maniera profonda se ne accorge. Inoltre all’epoca gli assassini nel cinema spesso erano degli psicopatici che uccidevano perché non gli funzionava bene il cervello, io invece ho rovesciato questo che era divenuto un cliché ormai. Ovviamente non sarò stato il primo, però all’epoca si erano un po troppo livellate le motivazioni degli assassini nel nostro cinema ed io negli unici due film che ho realizzato di questo genere ho cercato di rompere determinati schemi. Ricordo che sul set di Solamente nero un giornalista de Il Gazzettino mi chiese perché stavo dirigendo un giallo, dato che venivo dalla sperimentazione, io risposi che tra i vari generi che avrei potuto scegliere per realizzare un’opera prima che potesse risultare anche commerciale avevo pensato che il thriller fosse l’deale in quanto mi permetteva di esprimere le tematiche di cui parlavo prima e poi perché in realtà si trattava di un ponte che riusciva a collegare piuttosto bene il genere e l’autoriale. Tra l’altro fare un thriller non è mica facile, anzi, tant’è vero che Lino Capolicchio, protagonista di Solamente nero, si chiedeva sempre: “Come mai di thriller se ne fanno tanti ma soltanto pochi sono belli e rimangono nella storia?” Lui era molto settario rispetto al cinema e sono fiero del fatto che avesse un’opinione elevata di me e del nostro film. Non era facile recevere complimenti da parte sua. Spesso si pensa al film di genere come a qualcosa di meno complesso dell’autorialità ma è qui che si commette l’errore, perché se in un’opera inserisco cose mie allora sto già lavorando come autore. Basti pensare ad Hitchcock o a Leone. Poi vorrei sottolineare che è ben più complesso realizzare un film di genere thriller che un film totalmente libero in cui puoi esprimerti come vuoi, lì invece hai degli stilemi che devi rispettare, devi far paura e allo stesso tempo mantenere una certa originalità.
Ha mai preso spunto da un incubo per scrivere o dirigere una determinata scena?
No, assolutamente no. Contrariamente a Dario Argento che dice spesso di fare i film partendo dai propri incubi, o a Fellini che lavorava sul mondo dei sogni, devo dire che non ho mai preso spunto da quella determinata materia. Al contrario, in questi ultimi anni finalmente ho ripreso a sognare mentre prima sognavo decisamente poco. Negli unici incubi che facevo un tempo ricordo che mi vedevo valare come Superman per poi schiantarmi al suolo, svegliandomi di soprassalto preso dall’angoscia. Non so se questo incubo a livello inconscio abbia poi lavorato sulla mia fantasia generando la scena della caduta dal campanile in Solamente nero. Magari uno psicologo potrebbe vederci dei legami, chi lo sa.
Qual era invece la sua più grande paura da bambino?
L’inferno. Quand’ero piccolo, intorno ai sei anni circa, mia madre mi leggeva La Divina Commedia su un’edizione grande con le illustrazioni di Doré e quindi ascoltando e vedendo queste immagini raccapriccianti mi venivano gli incubi e ricordo che mi sveglaivo di notte piangendo urlando: “Mamma…” Quindi la paura dell’inferno, di questo luogo dove bruci, dove sei condannato, mi è rimasta dentro così come la paura dell’aldilà. Io non sono un perfetto credente però non sono ateo, preferisco definirmi più un agnostico. Mi barcameno spesso in queste paure, così come l’ossessione che ho per il mio corpo dopo essere morto, infatti mi voglio far cremare perché ho paura di essere messo in una bara ancora vivo e di svegliarmi dopo essere stato sepolto come nel film di Freda, il maestro di Mario Bava. Sicuramente la paura del peccato e del castigo mi hanno perseguitato molto da bambino, anche perché facevo il chirichetto, poi però avendo visto molte pellicce sfoggiate assieme ai gioielli delle signore che venivano a messa e cose simili, gente che era lì soltanto come pura messa in scena e che non scoltavano il prete e che dopo la predica erano peggio di prima, pieni di falsa fede e cristianità, decisi pian piano di allontanarmi da quel contesto. Anni dopo decisi di mettere tutto questo vissuto nei miei film. Il sacrestano di Solamente nero è ispirato alla mia infanzia, quando andavo a giocare a pallone al patronato e lui faceva da arbitro, così come il prete che paga le proprie colpe secondo una giustizia divina. Insomma, mi è rimasto molto del mio passato all’interno della liturgia e del sentimento religioso.
Quindi in qualche modo l’incubo dell’infanzia l’ha riportato anni dopo nel cinema?
Si, è vero. La mia infanzia, riflettendoci, rientra molto nei miei thriller.
L’artista, data la sua estrema sensibilità, probabilmente è più a rischio di soccombere al malessere a causa della sua estrema sensibilità. L’arte serve a questo? a sublimare le proprie paure?
Si. Ha utilizzato la parola giusta. Si soffre di più, perché chi si pone determinate domande non vive apparentemente felice come coloro che vivono semplicemente in base a cosa gli passa il supermercato. Probabilmente è un tratto che accomuna tutti gli artisti, o almeno una buona parte.