Io sono leggenda. Gian Ruggero Manzoni, per nostra fortuna, è ancora vivo. Solo che la sua vita è già, da anni, un progetto romanzesco, potrebbe averla narrata Plutarco (in parallelo, chessò, con Zarathustra o Belisario), potrebbe averla raffinata Marcel Schwob o Michele Psello, che godeva nell’istoriare le candide navate di Bisanzio con sordidi pettegolezzi e languide lussurie. Gian RuggeroManzoni ha avi mitici (che affogano la paludosa origine fin nella genia di Alessandro Manzoni, che si sfogano nella follia artistica di Piero Manzoni), di cui ha narrato, tra lucori sinistri e ambiguità, le gesta (nel libro I teatranti perduti, Albatros, 2013).
Lui stesso, “Gianruggente” Manzoni è un mito: educato «fin da giovanissimo» a studi filosofici, esoterici, cabbalisti, a vent’anni viene beccato nella Bologna squassata dalla “guerra civile” con armi a bordo, patteggia, si rende reperibile per anni dalle forze dell’ordine. Le quali, ogni tanto, lo mandano, pistola in pugno, in diversi contesti di guerra. Il nostro però oltre la mimetica ha il cuore vandeano tatuato sul petto e una furia letteraria addosso. Manzoni è incontenibile, scontroso, polimorfico. Geniale. Per questo non risulta nei mortiferi referti antologici delle muscolari case editrici. Non sai come afferrarlo. Come artista è nel gruppo della Transavanguardia, con Enzo Cucchi e Mimmo Paladino; nel 1983 dialoga con Keith Haring e l’anno dopo, su invito di Maurizio Calvesi, partecipa alla XLI Biennale di Venezia. In Germania è al fianco di Georg Baselitz e di Anselm Kiefer, in Italia lavora con Andrea Pazienza e dialoga con Giovanni Testori. Alcune fotografie lo immortalano al fianco di Lucio Dalla, di Salvatore Accardo, di Valerio Magrelli. Fonda riviste (Origini, Ali), fonda cenacoli artistici (che si consolidano nel chiostro di alcuni libri programmatici come Oltre il tempo e Nuova Vandea) con cannibale generosità, collabora con musicisti come Brian Eno e John De Leo.
Gli danno del reazionario, dell’ateo, del qualunquista, del bullo, del buono, sta a metà tra il killer e il monaco, lo credono un superuomo, un nichilista, un rivoluzionario, e lui nello stesso tempo traduce il libro dell’Esodo e quello della Genesi e si candida Sindaco di Lugo, la sua città, città di eroi (l’asso Francesco Baracca) di geni (il matematico Gregorio Ricci Curbastro) e di truffatori (Charles Ponzi), nel 2014, con spirito donchisciottesco e vagamente dannunziano. Soprattutto, però, Manzoni è un poeta. E un romanziere. Dalla bibliografia dilagante: 22 libri poetici e 13 romanzi. A cui si devono aggiungere una ventina di volumi sparsi, compreso il libro d’esordio, il Dizionario del linguaggio giovanile pubblicato per Feltrinelli, nel 1980. Semplificando all’osso, 35 anni di misterica e micidiale attività letteraria semiclandestina: i romanzi più belli di Manzoni sono Caneserpente (
In compilazione di una propria mitologia quotidiana, poi, è Manzoni stesso, in un libro edito da Il Bradipo, a suggerire l’epopea della figlia, Maria Virgilia Manzoni, ventenne, che fotografa con delicata violenza, Brighton. «Nessun fantasma ci assale con volti più diversi della malinconia», insegna Manzoni. La leggenda continua.
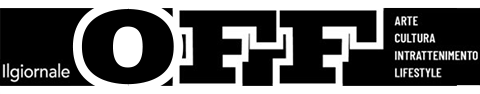
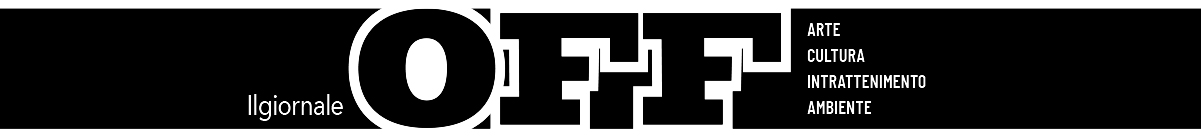

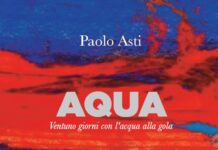






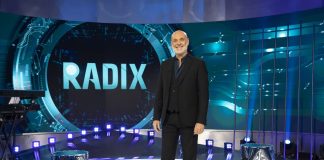


Bellissimo. Storicamente la questione della transavanguardia è difficile sostenerla. Non c’è nella mostra dell’80 a Basilea-Essen-Amsterdam, nè nella sezione Aperto della Biennale che sono state propedeutiche alla transavanguardia. Nè lavora con le gallerie che ne hanno sostenuto lo sviluppo. Avreste dovuto dire che ne frequentava l’ambiente. La storia non si cambia. Si può studiare però. E non è inventandola che si fa un piacere a un artista come lui.
Comments are closed.