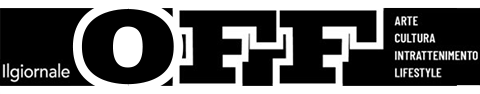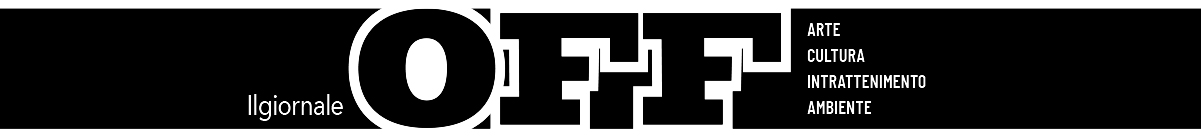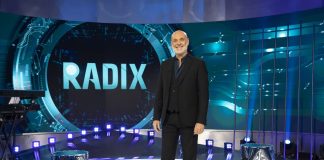Le maschere hanno da sempre esercitato un fascino magnetico sull’essere umano, assumendo ruoli molteplici nella storia dell’arte, della cultura e della società. Esse non sono solo strumenti di travestimento, ma vere e proprie espressioni di un’identità culturale profonda e di un linguaggio estetico che trascende il tempo.
Il Carnevale è un periodo dell’anno in cui la maschera diventa protagonista, trascendendo la semplice funzione di travestimento per assumere significati culturali, sociali e artistici profondi. Dietro ogni maschera si cela un’identità, un rito, una storia che si rinnova ogni anno in una danza tra il passato e il presente.
In questa occasione, vogliamo soffermarci su un aspetto meno conosciuto ma di grande fascino: le maschere sarde. Queste non sono solo elementi decorativi o di spettacolo, ma rappresentano una testimonianza vivente di antichi riti propiziatori e di un’estetica potente e primordiale che ha influenzato anche il mondo dell’arte. Dal loro legame con i cicli della natura alle connessioni con il primitivismo artistico, le maschere della Sardegna ci permettono di esplorare il significato più profondo dell’atto di mascherarsi e della trasformazione dell’individuo attraverso il rito.
Le maschere del Carnevale sardo, noto come Carrasegare, affondano le radici in antichi riti pagani legati al ciclo della vita, della morte e della rinascita. Austis, con le sue figure di Sos Colonganos e S’Urtzu, offre un esempio emblematico di come le maschere possano incarnare non solo un’estetica, ma anche un profondo significato rituale.
Sos Colonganos sono maschere ricoperte di pelli ovine, con volti in sughero decorati con rami di corbezzolo, simbolo di resistenza e rinnovamento. Invece di campanacci, portano ossa di animali, evocando il concetto di sacrificio e rinascita. S’Urtzu, invece, rappresenta la vittima sacrificale, ricoperto da pelli di cinghiale e costretto a dimenarsi sotto i colpi dei Bardianos, i guardiani del rituale.
Oltre a queste figure, tra le maschere più iconiche della tradizione sarda troviamo i Mamuthones e gli Issohadores, protagonisti del Carnevale di Mamoiada. I Mamuthones indossano pesanti pelli scure e maschere di legno dal volto severo e misterioso, mentre portano sulle spalle campanacci che risuonano a ogni loro passo. Il loro incedere cadenzato e solenne richiama antichi rituali propiziatori e simbolizza il rapporto tra l’uomo e la natura, tra il caos e l’ordine. Gli Issohadores, invece, vestiti con abiti bianchi e rossi, si muovono con agilità e usano una fune per “catturare” gli spettatori, in un gesto che rappresenta la fortuna e la protezione della comunità.
A livello estetico, queste maschere si caratterizzano per la loro essenzialità e il loro legame con i materiali naturali, evocando un senso di primitivismo che si ritrova anche in alcune correnti artistiche del Novecento.
L’arte primitiva ha influenzato in modo significativo numerosi artisti moderni. Pablo Picasso, ad esempio, ha tratto ispirazione dalle maschere tribali africane per la realizzazione di opere iconiche come Les Demoiselles d’Avignon (1907). Questo dipinto segna una svolta nell’arte moderna, evidenziando la potenza espressiva delle forme semplificate e delle geometrie aggressive, elementi che si ritrovano anche nelle maschere tradizionali.
L’uso di materiali grezzi, come il sughero e le pelli animali nelle maschere sarde, si collega a una ricerca di autenticità e di connessione con la natura, principi che ritroviamo nel movimento dell’arte povera, sviluppatosi in Italia negli anni Sessanta. Artisti come Michelangelo Pistoletto e Jannis Kounellis hanno esplorato il rapporto tra materiali organici e significati simbolici, proprio come le maschere tradizionali sarde incarnano la fusione tra estetica e ritualità.
Un altro importante riferimento è l’opera di Emil Nolde e degli artisti dell’Espressionismo tedesco, che hanno utilizzato volti stilizzati e deformati per esprimere emozioni profonde e stati d’animo ancestrali. Le maschere sarde condividono questa tensione espressiva, evocando sentimenti di inquietudine e sacralità.
Anche l’arte performativa contemporanea si ricollega alla simbologia delle maschere. Artisti come Marina Abramović e Joseph Beuys hanno integrato maschere e costumi rituali nelle loro performance, sottolineando il valore simbolico della trasformazione e della connessione con le radici antropologiche.
Nel mondo moderno, le maschere continuano a svolgere un ruolo chiave, sia nel contesto spettacolare che in quello identitario. Esse rappresentano una tensione tra il nascondere e il rivelare, tra il reale e l’immaginario, tra il passato e il presente.
Oggi, il concetto di maschera è ripreso in molteplici ambiti artistici e culturali. Nel teatro sperimentale, nel cinema e nella moda, le maschere sono ancora strumenti di trasformazione e riflessione sull’identità. Maison come Alexander McQueen e Gucci hanno reinterpretato l’idea di maschera nelle loro collezioni, confermando il potere evocativo di questi oggetti arcaici.
Le maschere sarde, con il loro aspetto grezzo e potente, dimostrano che l’estetica non è solo una questione di bellezza formale, ma un mezzo per trasmettere significati profondi e senza tempo. Attraverso l’arte e la tradizione, la maschera diventa uno strumento di metamorfosi, un ponte tra il visibile e l’invisibile, tra il sacro e il profano.
Nel panorama artistico attuale, la maschera continua a essere un potente strumento espressivo, capace di esplorare identità fluide, narrazioni collettive e la memoria culturale di popoli e tradizioni. In ogni epoca, la maschera ci sfida a guardare oltre la superficie, ricordandoci che l’essenza di ogni identità è in continua trasformazione.