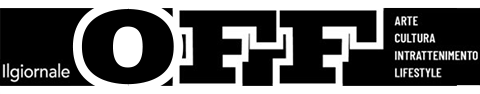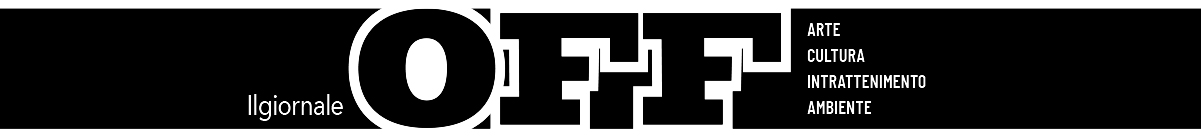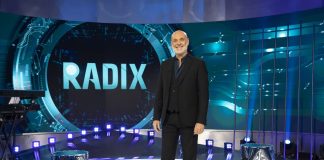In un’epoca in cui ideologia woke e cancel culture portano all’ammasso il cervello prendendosela con Dumbo e Biancaneve, che ne è della fiaba come genere letterario?
Ne parliamo con Giuseppe Reguzzoni, docente, traduttore e saggista, giornalista pubblicista e autore di Il risveglio di Rosaspina. Una prospettiva sulla Fiabe dei Grimm (Marcianum Press, 2024, 176 pagine), che sarà presentato venerdì 27 settembre alle ore 21, presso il Circolo Ra Ca dur Barlich a Varese in un incontro moderato da Andrea Mascetti.

Il Risveglio di Rosaspina. Una prospettiva sulle fiabe dei Grimm è un saggio incentrato sulla riscoperta di genere letterario fra i più antichi, “disseppellito” dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm nel pieno di quella rivoluzione industriale che con la tecnologia scalzò l’immaginario popolare tradizionale dall’orizzonte della cultura.
Ma la fiaba oggi, in un’epoca che vogliono farci intendere “liquida” sulla falsariga di Zygmunt Bauman, riemerge come un fiume carsico dai miti antichi e dalle narrazioni popolari, magari anche come reazione a quello che Heidegger avrebbe definito il dominio della tecnica. Forse perché il falso mito del progressismo non riesce a dare le risposte alle domande fondamentali dell’esistenza, come del resto non ci è riuscita l’impresa scientifica (citofonare Wittgenstein).
Professor Reguzzoni, se etimologicamente la superstizione è ciò che resta della verità, che cos’è la fiaba?
La fiaba è una forma di narrazione simbolica. È una rappresentazione di verità nascoste nell’inconscio dei popoli che illuminano aspetti, a loro volta nascosti, della psiche umana nel suo rapporto con la realtà. Il simbolo dice sempre che oltre quello che si vede o si sente c’è altro, c’è molto di più. Il fraintendimento delle fiabe, non solo quelle dei Grimm, è dovuto alla perdita di questa dimensione simbolica. Mircea Eliade spiegava che la dimensione simbolica ha tre grandi forme: quella religiosa, quella onirica e quella poetica. La fiaba è al punto di incontro di tutte e tre queste forme e ha a che fare con la realtà psichica, personale e collettiva; è archetipo, e non può essere presa alla lettera.
E’ vero che i fratelli Grimm depurarono alcune fiabe di parte dei loro contenuti?
Nel volume ricostruisco, sulla scorta di diversi studi filologici, il percorso compositivo delle fiabe dei Grimm. Senza un minimo di rigore filologico non si può nemmeno avviare un serio lavoro interpretativo. Nel corso delle sette edizioni, tra il 1812 e il 1857, molte cose furono cambiate rispetto alla prima versione della raccolta. Furono aggiunti nuovi testi e ne furono tolti altri. Su tutto questo incise molto la prospettiva puritana di Wilhelm Grimm, quello dei due fratelli che più direttamente curò le ultime edizioni. D’altra parte, le fiabe, anche quando avevano precedenti letterari scritti e importanti – come Perrault o Basile – furono recepite principalmente da tradizioni orali, che per definizione sono come corsi d’acqua: scorrono, sono fluide, non possono mai essere trattenute del tutto. Sicuramente, per esempio, rispetto alla prima edizione, che è la più vicina alle tradizioni popolari, le ultime appaiono epurate da richiami esplicitamente sessuali, in linea appunto con il rigorismo calvinista dei Grimm, soprattutto di Wilhelm. A tutto questo si aggiunge la volontà, tutta romantica, di preservare il patrimonio germanico più antico, magari forzando determinate fonti o passandone in silenzio delle altre.
Il Suo saggio ha un taglio prevalentemente storico o ha anche prospettive che spaziano su altri punti di vista culturali?
La prima parte del mio saggio è di taglio storico-filologico, la seconda è una guida all’interpretazione delle Fiabe, alla luce delle scienze umane e sulla base delle diverse tradizioni che in esse confluiscono. Ho scelto di analizzare alcune fiabe e di proporne delle letture da diversi punti di vista. La prima e più immediata forma di interpretazione è il modo in cui noi presentiamo le fiabe e, pertanto, i bambini, non hanno bisogno che gliele spieghiamo. Spiegarle, però, può essere utile a noi proprio per “interpretarle”, quasi come attori, quando gliele raccontiamo. Non è un caso che tra i grandi ammiratori dei Grimm ci siano stati pensatori come Kierkegaard, che ne fece delle metafore esistenziali, Freud e Jung, che ne diedero una lettura psicoanalitica (che anch’io in parte riprendo, anche in dialogo con figure contemporanee come Marie Louise von Franz ed Eugen Drewermann) e, persino Marx e Gramsci, che consideravano le fiabe come il sospiro delle classi popolari oppresse. Insomma: ce n’è per tutti e c’è spazio per tante letture. Nelle Fiabe dei Grimm sono presenti diversi strati di significato da quello pagano a quello cristiano medievale, sino, appunto, al biblicismo riformato. L’unica cosa da non fare, che è poi la più stupida e priva di ogni fondamento, è prendere le fiabe alla lettera, che è appunto quello che fa la Cancel culture in ossequio al Politicamente Corretto. Pensi che in Germania c’è stata una ministra che ha proposto di vietarne o almeno emendarne la lettura perché sarebbero troppo crude e sessiste.
Quali sono le fiabe italiane per eccellenza?
Le fiabe italiane hanno per loro natura un carattere fortemente regionale, ma se proprio devo rispondere cito Giambattista Basile, con Lo Cunto de li cunti – e siamo a Napoli all’inizio del secolo XVII – , o Karl Felix Wolf, con le leggende delle Dolomiti (ma ha senso applicare a questi esempi l’attuale concetto di Italia?) o ancora Emma Parodi con le fiabe toscane. Rimanendo in Toscana, non si può dimenticare Collodi con il suo Pinocchio, una delle opere italiane più tradotte al mondo. C’è la fiaba popolare e poi c’è la fiaba d’autore, che della prima riprende lo spirito e la dimensione misteriosa. Qui, il primo nome che mi viene in mente è Calvino, con Le fiabe italiane (che, infatti, riprendono molte tradizioni locali), ma la dimensione fiabesca è presente anche in Buzzati, a cominciare dal Segreto del Bosco Vecchio.
La fiaba è un genere per ragazzi o per adulti?
Le rispondo citando C.S. Lewis, che scrive: “Un libro non merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a cinquanta”. Su questo rinvio alla bella postfazione al mio libro, scritta dal mio amico Paolo Gulisano, che, a sua volta, cita G. K. Chesterton (di cui è un grande esperto): “Le fiabe sono più che vere: non perché ci dicono che i draghi esistono, ma perché ci dicono che possono essere sconfitti”.
Se dici fiaba dici anche territorio e noi al Giornale OFF siamo molto attenti all’identità culturale dei territori: cosa si può fare secondo Lei per valorizzare un genere letterario che è anche in certo senso territoriale?
Raccontarle e farle raccontare, magari anche nelle lingue regionali. Ci sono diverse raccolte, ben fatte, come quella delle fiabe lombarde curata da Adalinda Gasparini, o le traduzioni in milanese di fiabe e favole classiche a cura di Pierluigi Crola. La rivista Terra Insubre da anni lavora anche su questi temi e ha proposto ottimi strumenti. Tra l’altro nell’edizione definitiva delle fiabe dei Grimm, un buon numero di fiabe sono rimaste in diversi dialetti di varie regioni della Germania. Nel corso delle diverse edizioni i Grimm hanno ridotto le parti in dialetto, ma non le hanno mai volute eliminare del tutto. La lingua non è un fattore secondario nella tutela dell’identità o di ciò che ne rimane. Poi, in ogni caso, le fiabe parlano sempre anche di usi e costumi che sembrano fuori dal tempo, ma che hanno dei riferimenti culturali identificabili e quindi “introducono” a un determinato mondo, fatto di paesaggi, di luoghi, di figure tradizionali. Anche la rivista Linea Tempo, che si occupa di didattica, ha dedicato recentemente un numero monografico proprio all’attualità educativa delle fiabe. Vanno lette in famiglia e a scuola, ma si devono incrementare le letture pubbliche, non solo nelle biblioteche, ma anche in luoghi suggestivi, come boschi, parchi, castelli o ville storiche.